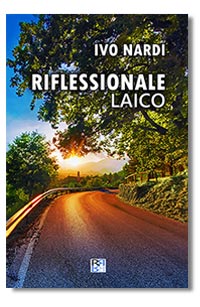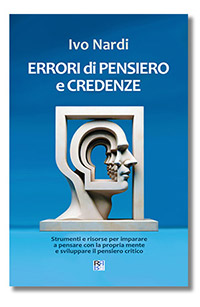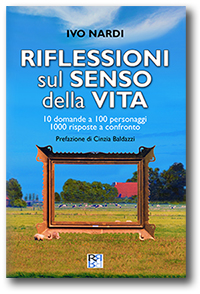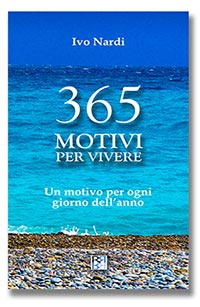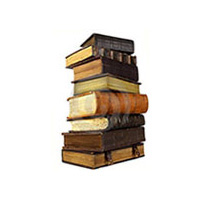
Enciclopedia Indice
Richard Rorty
Richard McKay Rorty (New York, 4 ottobre 1931 – Palo Alto, 8 giugno 2007) è stato un filosofo statunitense, uno dei più influenti e controversi pensatori del tardo XX secolo. Esponente del neopragmatismo (o "nuovo pragmatismo"), Rorty ha criticato radicalmente le pretese fondazionaliste e rappresentazionaliste della filosofia moderna, proponendo una visione della filosofia come conversazione edificante piuttosto che come disciplina in grado di scoprire verità oggettive e universali. La sua opera ha avuto un impatto profondo non solo in filosofia analitica e continentale, ma anche in teoria letteraria, studi culturali, scienze politiche e dibattito pubblico sul liberalismo e la democrazia.
Biografia
Richard Rorty nacque a New York in una famiglia di intellettuali di sinistra. I genitori, James e Winifred Rorty, erano attivisti, poeti e sostenitori del socialismo non stalinista; il nonno materno, Walter Rauschenbusch, fu una figura centrale nel movimento del Social Gospel protestante. Fin da adolescente Rorty soffrì di depressione e ossessioni, esperienze che influenzeranno il suo rifiuto successivo di ogni forma di essenzialismo psicologico o metafisico.
Entrò all'Università di Chicago a soli 15 anni, dove ottenne il bachelor's degree (1949) e il master's degree (1952) in filosofia, studiando sotto Richard McKeon. Conseguì il dottorato a Yale nel 1956 con una tesi sul concetto di potenzialità in Aristotele. Dopo il servizio militare (1957-1958), insegnò al Wellesley College (1958-1961), poi a Princeton (1961-1982), dove divenne Stuart Professor of Philosophy. Nel 1982 passò all'Università della Virginia come Kenan Professor of Humanities e, dal 1998 fino al ritiro nel 2005, insegnò letteratura comparata a Stanford.
Si sposò due volte: prima con Amélie Oksenberg (1954, un figlio, Jay), poi con la bioeticista Mary Varney (1972, due figli). Morì nel 2007 per complicanze da cancro al pancreas.
Pensiero filosofico
Il percorso intellettuale di Rorty può essere diviso in tre fasi principali:
- Fase analitica (anni '60) Inizialmente inserito nella filosofia analitica, curò l'antologia The Linguistic Turn (1967), che raccoglieva i testi classici del "giro linguistico". In quel periodo difendeva posizioni eliminativiste in filosofia della mente (influenzato da Wilfrid Sellars e Willard Van Orman Quine).
- La svolta antiprappresentazionalista (1979) Con Philosophy and the Mirror of Nature (1979), il suo libro più celebre, Rorty compie una rottura decisiva. Critica l'idea che la mente sia uno "specchio della natura" capace di rappresentare oggettivamente la realtà. Smantella tre pilastri della filosofia moderna:
- il fondazionalismo epistemologico (non esistono "fondamenti" indubitabili del sapere);
- il rappresentazionalismo (il linguaggio non "rispecchia" il mondo);
- il privilegio epistemologico della filosofia (non è una "tribunale della ragione" superiore a scienza, arte o letteratura).
Propone invece una filosofia "edificante" (ispirata a Wittgenstein, Heidegger e Dewey): il compito del filosofo non è scoprire verità eterne, ma continuare la "conversazione dell'umanità", proponendo nuovi vocabolari per affrontare i problemi contingenti.
- Neopragmatismo maturo (anni '80-'90) Rorty rilancia il pragmatismo classico americano (soprattutto Dewey, ma anche James e Peirce rivisti) contro ogni forma di essenzialismo. In Consequences of Pragmatism (1982) e Contingency, Irony, and Solidarity (1989) afferma che:
- la verità non è corrispondenza con la realtà, ma ciò che funziona nella pratica sociale ("ciò che i tuoi contemporanei ti lasciano dire senza obiettare");
- il linguaggio, il sé e le comunità sono contingenti storici, non necessari;
- l'ironista liberale è la figura ideale: chi riconosce la contingenza dei propri valori ultimi, ma rimane impegnato nella riduzione della crudeltà e nell'espansione della solidarietà.
Rorty rifiuta sia il relativismo nichilista sia l'oggettivismo platonico-cristiano: la solidarietà non ha bisogno di fondamenti metafisici, basta l'immaginazione empatica (influenzata da romanzi e letteratura).
Influenza e critiche
Rorty è stato un "ponte" tra tradizione analitica e continentale, influenzando pensatori come Jürgen Habermas (con cui polemizzò), Gianni Vattimo, Robert Brandom, Nancy Fraser e Judith Butler. Negli studi letterari e culturali ha contribuito al superamento del canone oggettivista.
Le critiche principali:
- Da parte di realisti e fondazionalisti (Hilary Putnam, John McDowell): Rorty cadrebbe in un relativismo performativo contraddittorio.
- Dalla sinistra radicale: il suo liberalismo riformista sarebbe troppo timido (non abbastanza marxista o post-strutturalista).
- Da conservatori: il rifiuto di verità oggettive minaccerebbe i fondamenti morali della società.
Ciononostante, la sua visione di una democrazia come "comunità di conversazione" senza fondamenti metafisici rimane una delle proposte più originali per pensare la politica post-metafisica.
Consigliamo la lettura di
Rorty e l'ironia liberale di Massimo Fontana
Bibliografia
RORTY RICHARD, The Linguistic Turn: Recente Essay in Philosophical Method, Chicago 1967, tr. it. S. Velotti, La svolta linguistica, Milano 1994.
RORTY RICHARD, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton 1979, tr. it. G. Millone e R. Sallizone, La filosofia e lo specchio della natura, Milano 1986.
RORTY RICHARD, Consequences of Pragmatism, Minneapolis 1982, tr. it. F. Elefante, Conseguenze del pragmatismo, Milano 1986.
RORTY RICHARD, Di là dal realismo e dall'antirealismo: Heidegger, Fine, Davidson e Derrida, tr. it. di Maurizio Ferraris, "Aut Aut", 1987, n. 217-218, pp.101-119.
RORTY RICHARD, Prendere sul serio la filosofia (materiali sul caso Heidegger), tr. it. di Pietro Kobau, "Aut Aut", 1988, n. 226-227, pp. 133-140.
RORTY RICHARD, Rappresentazione, pratica sociale e verità, in Vattimo Gianni, Filosofia '88, Roma-Bari 1989, pp. 209-225.
RORTY RICHARD, Contingency, Irony and Solidarity, Cambridge 1989, tr. it. G. Boringhieri, La filosofia dopo la filosofia, Roma 1989.
RORTY RICHARD, Objectivity, Relativism and Truth. Philosophical Papers Vol. I, Cambridge 1991, tr. it. Massimo Marraffa, Scritti filosofici I, Roma 1994.
RORTY RICHARD, Essay on Heidegger and Others. Philosophical Papers Vol II, Cambridge 1991, tr. it. B. Agnese, Scritti filosofici II, Roma 1993.
RORTY RICHARD, Una visione pragmatista della razionalità e della differenza culturale, tr. it. di A. M. Morazzoni, "Aut Aut", 1992, n.251, pp.109-124.
RORTY RICHARD, Il progresso del pragmatista, in ECO UMBERTO, Interpretation and Overinterpretation, Cambridge 1992, tr. it. S. Cavicchioli, Interpretazione e sovrainterpretazione, Milano 1995.
RORTY RICHARD, Truth and Progress. Philosophical Papers Vol. III, Cambridge 1998, tr. it. di G. Rigamonti, Verità e progresso, Milano 2003.
RORTY RICHARD, L'essere che può venir compreso è linguaggio, "Iride", agosto 2000, 13 (30), pp. 313-322.
RORTY RICHARD, Quine. La verità non è mai un dogma, "La Stampa", 17 febbraio 2001.
RORTY RICHARD, Siamo tutti figli di un dio privato, "Reset", pubblicato su "Il Corriere della Sera", 23/01/02.
RORTY RICHARD, Il futuro della religione, Milano 2005 (tr. it. di Santiago Zabala. Dialogo tra Richard Rorty, Gianni Vattimo e Santiago Zabala).
RORTY RICHARD, À quoi bon la vérité?, Paris 2005, tr.it. di Giorgia Viano Marogna, A cosa serve la verità, Bologna 2007.
RORTY RICHARD, Un’etica per i laici, Torino 2008 (tr. it. di Elena Mortarini e prefazione di Gianni Vattimo).
RORTY RICHARD, Verità e libertà, "Transeuropa", Massa 2008 (raccolta postuma di saggi curata da Gianni Vattimo e Santiago Zabala).
SCRITTI SU RORTY
ARGYROS ALEXANDER J., Chaos versus contingency theory: epistemological issues in Orwell's "1984", "Mosaic", 1993, Vol. 26, p. 34-66.
BARONCELLI FLAVIO, Rorty, prima viene il dialogo, "Il Sole 24 Ore", 13 maggio 2001.
BERNI STEFANO, La post-filosofia di Richard Rorty, "Ponte 46", 1990, n.9, p.139.
BERNSTEIN J. M. , Richard Rorty Philosophical Papers, "J. Brit. Soc. Phenomenol. 23", 1992, n. 1, pp. 76-83.
CARLI EDDY, Cervelli che parlano. Il dibattito su mente, coscienza e intelligenza artificiale (intervista-colloquio con Richard Rorty), Milano 1997.
CONWAY D. W., Thus spoke Rorty. The perils of narrative self-creation, "Philosop. Lit.", 1991, n.1, pp. 103-110.
DUPRé LOUIS, Postmodernity or late modernity? Ambiguities in Richard Rorty's thought, "The Review of Metaphisics", 1993, Vol. 47, pp. 66-83.
FERRARIS MAURIZIO, Richard Rorty e la transizione dall'epistemologia all'ermeneutica, "Aut Aut", 1986, n.216, pp.123-129.
GAL OFFRE, Esse and Rorty on Metaphor. Rhetoric in Contemperare Philosophy, "J. Specul. Philos.", 1995, n. 2, pp. 125-146.
GARRISON JIM, A Strong Poet's Perspective on Rorty, "Sud. Philos. Cd", 1993 (12), n. 2-4, pp. 213-221.
GARRONI EMILIO, Narrazione e filosofia, In AA. VV., Teoria e pratica della scrittura creativa, a cura di T. De Mauro, P. Pedace e A. G. Stasi, Roma 1996 (p.133 il saggio di Petrini su Rorty).
GRIFFIN PAUL F., Changes of Being Kind: Rorty. Irony, and Teaching Modern Literature, "College Literature", 1991, Vol. 18, pp. 107.
LONGFORD GRAHAM, "Sensitive Killers, cruel aesthetes, and pitiless poets": Foucault, Rorty, and the ethics of self-fashioning, "Polity", 2001, Vol. 33, pp. 56-66.
MADDALENA G., Richard Rorty, ovvero come un filosofo diventa umano, "T. Pres", 1989, n.106-108, pp. 29-38.
MANNO AMBROGIO GIACOMO, La dialettica decostruttiva di Richard Rorty e il suo esito agnostico, "Sapienza", o-d 2001, 54 (4), pp. 433-454.
MARCHETTI LUCA, "La proposizione una cosa singolare!" Rorty lettore di Wittgenstein, "Il cannocchiale", gennaio - aprile 2000, pp. 49-69.
MARCONI DIEGO, Hegel's Definition of Idealism, Rorty and Feyerabend, "Epistemologia", 1986 (9), pp. 95-104.
MASTROLILLI PAOLO, 2000 la fantascienza al potere (intervista a Richard Rorty), "La Stampa", 7 gennaio 2000.
MC CLEARY, Richard Rorty. Philosophical Prose and Pratice, "Philosophy 68", 1995, n. 2, pp. 79-89.
PIAZZA MARIO, Generi e testi: sul letterario e il filosofico, "Iride", Dicembre 1989, 11 (25), pp. 595-605.
POLITI G., Appuntamenti con la filosofia 2. Benjamin, Rorty…,"Terzo Millennio", 12, Milano, 1996, p. 256 .
RAMBERG BJORN, Un uomo senza argomenti? Rorty e gli strumenti della filosofia, "Iride", aprile 2000, 13 (29), pp. 51-59.
RESTAINO FRANCO, Rorty e Bernstein. Neopragmatismo e riscoperta della filosofia europea, "Giornale critico della filosofia italiana", LXVII, 1987, n.1, pp.1-22.
RESTAINO FRANCO, Filosofia e postfilosofia in America. Rorty, Bernstein, MacIntyre, Milano 1990.
SANTUCCI ANTONIO, Conseguenze delle 'Consequences of Pragmatism' di Richard Rorty, "Rivista di filosofia 80", n° 3, dicembre 1989, p.431.
TREMBATH PAUL, The Rhetoric of Philosophical 'Writing". Emphatic methapors in Derrida e Rorty, "Journal of Aesthetic and Art Criticism", 1989 (47), n. 2, pp. 169-173. WEST CORNEL, The American Evasion of Philosophy. A Genealogy of Pragmatism, 1989, tr. it. F. R. Recchia Luciani, La filosofia americana, Roma 1997.
Libri pubblicati da Riflessioni.it
RIFLESSIONI SUL SENSO DELLA VITA 365 MOTIVI PER VIVERE |
|