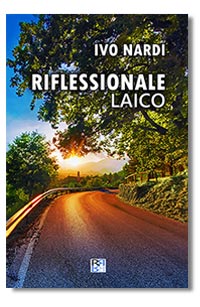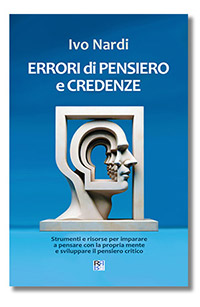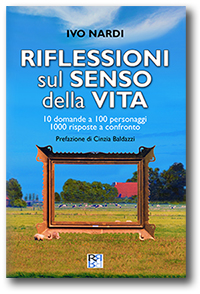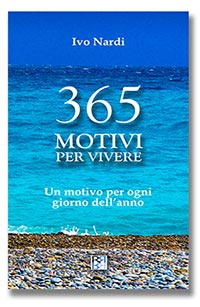Riflessioni sull'Esoterismo
di Daniele Mansuino indice articoli
L’arazzo della creazione
Agosto 2025
Quando Jalal al-Din Rumi (1207-1273) paragonava la creazione (o la realtà formale, o il piano della realtà oggettiva) a un arazzo in cui non vi è breccia, al di là dell’immagine poetica faceva un’affermazione molto precisa.
Sappiamo che nell’arazzo non vi è breccia perché possiamo muoverci in qualunque direzione dello spazio senza che mai la sua immagine venga meno.
Le maglie dell’arazzo vengono mantenute strette dal flusso delle informazioni sensoriali, che - procedendo da ogni suo punto - saturano la nostra mente ad ogni istante.
Questa potenza di emanazione non viene esercitata soltanto a beneficio dei nostri sensi, ma anche da ogni singolo punto dell’arazzo verso gli altri.
Infatti, come le tradizioni esoteriche affermavano da sempre, è stato appurato dalla scienza che, se influenziamo una parte dell’arazzo - o anche un suo singolo punto - con una nuova informazione, questa istantaneamente si trasmetterà all’intera struttura nella forma di alterazioni quantistiche.
Volendo dirlo in termini scientifici: potremmo paragonare il tessuto dell’arazzo a un superconduttore, oppure a una sostanza dotata della massima fluidità.
Le scienze umane sono ancora ben lontane dall’aver pienamente compreso come possa svolgersi un’attività al contempo tanto potente e tanto microscopica.
Ma una cosa possiamo dire: ovvero che, se portiamo avanti agli estremi l’immagine dell’arazzo, ed immaginiamo la realtà come una struttura bidimensionale - ebbene: ci accorgeremo che essa vibra, come è attestato dalla costante produzione di radiazioni che emanano da ogni punto; e poiché questa emanazione aumenta proporzionalmente alla densità della porzione dell’arazzo da cui proviene - ovvero: è più forte in presenza di forme - da questo deriva che è collegabile alla capacità di ospitare e trasmettere informazioni.
La vibrazione, ovviamente, è anche alla fonte della tridimensionalità dell’arazzo; e, probabilmente, anche della presenza di un numero di dimensioni superiore a quante i nostri sensi ne possano percepire.
L’ipotesi di una realtà pluridimensionale non è il volo di un’immaginazione eccitata, bensì un tentativo di dare una spiegazione all’innumerevole quantità di funzioni che l’arazzo condensa in un solo punto.
L’arazzo esprime le sue informazioni secondo un codice che i nostri sensi sono in grado di elaborare come un continuum, ed è questo a cui si riferisce il Come in alto, così in basso dell’Ermetismo.
Dall’alto (che è tale soltanto fino a che non capovolgiamo la scatola) ci vengono proposte informazioni sintetizzabili; in basso, l’essere umano ha una mente che, per quanto possano essere complesse, è in grado di decifrarle con relativa facilità.
Per questo è stato detto che, se vogliamo capire come funziona l’Universo, dovremmo studiare il funzionamento della nostra mente.
Il che non rappresenta una grande semplificazione - anzi, è forse più in basso che in alto ad emergere quanto sia necessaria l’interazione di un gran numero di leggi per rendere possibile l’interpretazione dell’arazzo da una porzione o da un punto; e sono leggi che la scienza va scoprendo a poco a poco, senza speranza (almeno per ora) di tradurle in una teoria globale.
Prendiamo ad esempio il senso della vista. Possiamo paragonare la retina ad una macchina per la decodifica dell’arazzo, equipaggiata con circa trecento milioni di recettori che trasformano i campi elettromagnetici delle immagini percepite in generatori di elettricità; e poi smistano la corrente da essi stessi prodotta entro circa un milione di assoni (conduttori nervosi) diversi.
Gli assoni fanno poi convergere gli impulsi elettrici nelle cellule bipolari, che li tramutano in un codice binario, e di lì alle cellule gangliari, che ne estraggono un codice unificato - tutto questo a livello istantaneo.
È da notare come queste operazioni compiute dal cervello siano analoghe al meccanismo per cui ogni punto dell’arazzo concentra le informazioni provenienti dal resto di esso, fino a proporcele in quel codice iper-semplificato che è la realtà formale.
Ancora una volta, come in alto così in basso.
Infine, tornando alla vista: la trasformazione di quelle che sono solo tenui scariche elettriche in immagini visive avviene ad opera di uno dei due nuclei del talamo, che le proietta sulla corteccia cerebrale - e questa è un’ulteriore conferma della nostra analogia, perché nella mente come nell’arazzo possiamo notare due funzioni: una inferiore fondata sul trattamento delle informazioni frammentate, ed una superiore che si occupa di unificarle.
Va detto che la sovrapposizione del sistema neuro-cerebrale a quello neuro-algoritmico (hardware-software) implica grandi problemi di codifica. I processi visivi sono caratterizzati dall’applicazione, da parte del cervello, di un vero e proprio carosello di codici interpretativi diversi; ed alcuni di essi sono analogici ed altri digitali, e la scienza è lontana dal comprendere come il miracolo delle loro istantanee trasposizioni sia possibile (se non ipotizzando che il processo abbia luogo al di fuori dallo spaziotempo che conosciamo, ovvero fuori dall’arazzo, o meglio a monte di esso).
Il continuum impenetrabile che caratterizza la nostra visione rimane tale anche se si considera il rapporto tra l’arazzo e la mente. La più evidente dimostrazione di questo sta nel fatto che è impossibile stabilire il momento, o il punto, in cui l’informazione oggettiva comincia a diventare un input sensoriale soggettivo.
Infatti, come la realtà formale modifica la propria struttura utilizzando varie scale temporali diverse (tanto una particella subatomica quanto una montagna sono parti della realtà, ma la prima dura un attimo, la seconda milioni di anni), altrettanto la nostra mente, per interpretarla, fa la stessa cosa, ricorrendo a cinque sensi ciascuno dei quali agisce in base a processi e tempi diversi dagli altri.
Guardando al modo in cui i nostri sensi interagiscono tra loro, non abbiamo più di fronte soltanto il sorprendente spettacolo di una catena di codici che si traducono l’uno nell’altro in modo fulmineo, come nel caso della vista: quello che entra in gioco è un sistema interconnettivo in grado di sincronizzare da due a cinque media diversi.
A sprazzi, abbiamo tutti sperimentato la sua esistenza; per esempio quando, mentre siamo concentrati a decifrare input informativi provenienti da una data fonte, all’improvviso se ne intromette uno di provenienza diversa. Allora, la momentanea difficoltà del cervello nel dare un senso a ciò che sta accadendo può raggiungere la nostra consapevolezza, ed avvertiamo un attimo di disagio (e, se ci facciamo caso, il disagio sarà più forte quando l’informazione intrusa proviene da un senso diverso da quello che stavamo usando in modo prioritario).
Ogni singolo senso ha ritmi di elaborazione diversi dagli altri: accelerano se il senso è più sollecitato, rallentano nella routine ordinaria - e siccome, a seconda della velocità, l’interpretazione degli input è affidata ad aree diverse della corteccia cerebrale, ci sono aree che si accendono e si spengono continuamente.
Sono anche variabili le modalità di interpretazione degli input da un’area all’altra - esempio lapalissiano: quando siamo sotto stress abbiamo pensieri che non ci vengono quando siamo tranquilli, e viceversa.
Ed ecco spiegate anche le scale temporali diverse - più informazioni, e/o più esigenze di coordinamento tra i sensi, significano tempi di elaborazione più lunghi, ed una conseguente estensione del nostro senso del presente - oh, il tempo è volato … (il che vuol dire: abbiamo incluso entro processi interpretativi simultanei degli input sensoriali che si erano generati successivamente).
È questo un fenomeno che si manifesta particolarmente nel pensiero astratto - quando siamo impegnati a leggere o a pensare, abbiamo certe volte l’impressione di andare fuori dal tempo.
La riflessione sulle scale temporali diverse è una chiave che consente di penetrare vari misteri dell’arazzo.
Per esempio, è una regola che ogni singola forma duri tanto più a lungo quanto più la sua esistenza si accorda con il progetto generale di cui l’arazzo è espressione - o, detto in termini meno deterministi: con le sue modalità organizzative.
Abbiamo già notato come all’apparire di ogni singola forma faccia da corrispettivo una maggiore densità dell’arazzo; ora, queste condensazioni (di norma limitate nel tempo e nello spazio) sono frutto di distorsioni nella circolazione di quattro forze - gravitazionale, di interazione debole, di interazione forte ed elettromagnetica.
Si tratta delle stesse quattro forze che gli esoteristi conoscono sotto il nome di Quattro Elementi - le cito qui senza addentrarmi nel problema delle loro corrispondenze con Aria, Acqua, Terra e Fuoco, che sono variabili e richiederebbero un discorso a parte.
Comunque, tanto le si consideri in qualità di forze che di Elementi, ciascuna di esse dà origine a una famiglia specifica di distorsioni, che tratteremo forse in un altro articolo.
Le distorsioni, cioè le forme, sono ciò che stimola il sistema cerebrale a prendere in considerazione una data sezione dell’arazzo.
Laddove non ci sono distorsioni, sembra che non ci sia nulla; però l’arazzo è potenzialmente pronto ad accogliere qualsiasi distorsione che potrebbe manifestarvisi (e, se si tratta di una forma materiale, anche a mettere in moto anche tutto il complesso delle forze invisibili che ne costituiscono il corredo - la gravità, la curvatura dello spazio, eccetera).
La forza sconosciuta che determina la comparsa delle distorsioni è stata battezzata forza repulsiva, così come la forza attrattiva è quella che le riassorbe.
Anche un fenomeno come la morte può essere spiegato attraverso l’azione della forza attrattiva, perché nell’ottica dell’arazzo, ehm, anche un essere umano è una distorsione.
Sebbene sia difficile immaginare perché l’arazzo generi le distorsioni (ogni gnostico e ogni teologo fornirebbero una spiegazione diversa), però è lecito affermare che ciascuna di esse incrementa le quattro forze, ovvero la complessità del creato, e di conseguenza l’impegno che dobbiamo profondere nell’interpretarlo.
Quanto più aumenta la forza attrattiva, tanto piùcresce anche la repulsiva; e quanto più aumenta la forza investita dall’arazzo in questo titanico braccio di ferro, tanto più accelera l’evoluzione, migliorando le nostre capacità di interconnessione neuronale, ed estendendo la capacità dei nostri cervelli di replicare l’arazzo.
Non è quindi sacrilega l’idea che l’essere umano voglia farsi simile a Dio: è Dio che lo vuole, alimentando un processo che si svolge - automaticamente e inevitabilmente - molto al di là del livello su cui la nostra volontà può esercitare la sua signoria.
La manifestazione di una forma, oltre a rendere l’arazzo più instabile, calca l’accento sull’aspetto tempo dello spaziotempo - infatti, la presenza di forme introduce inevitabilmente il concetto della loro relatività: se non per altro per il loro posizionamento reciproco, e per il fatto che le forme esistono nel momento in cui c’è qualcuno che le percepisce.
Le forme più instabili innescano una convergenza di informazioni verso la zona dell’arazzo in cui sono incluse (se mai qualcuno ne dubitasse, dovrebbe riflettere che non ci possono essere informazioni laddove non ci sono forme).
Qualsiasi spiegazione del mondo può dunque essere considerata un sintomo di instabilità locale dell’arazzo, il che la destituisce automaticamente da ogni pretesa di verità assoluta.
Abbiamo già visto quanto la materia sia indissolubilmente legata alle zone di instabilità; ma, d’altra parte, è anche vero che la sua densità determina una maggiore difficoltà nella circolazione delle informazioni, e quindi della convergenza delle informazioni nei singoli punti - il che è la fonte dell’incapacità dell’intelligenza umana di comprendere a fondo la struttura dell’arazzo, ovvero della nostra difficoltà di accedere al quadro globale.
Ci riesce invece perfettamente di percepire il colossale potenziale di auto-modificazione dell’arazzo - la sua motilità costante, che stimola le nostre menti senza tregua, anche nel sonno.
Troviamo alla sua fonte le strutture di base della realtà formale - le particelle, i campi e le forze descritte dalla fisica, eccetera.
Il loro corrispettivo nel microcosmo dell’uomo sono i fenomeni soggettivi, i pensieri e sensazioni, che delineano l’individualità umana analogamente a come la fisica delle particelle dipinge il mondo; e quest’ultima analogia non è altro che l’ennesima piccola pietra recata all’edificazione del Tempio che riassume l’arazzo e la mente, mostrandoci come la contrapposizione tra percezione soggettiva e realtà oggettiva non solo non sia insanabile, ma - di fatto - non esista neppure.
E tuttavia, è vero che il superare questa falsa contrapposizione è molto difficile, soprattutto per il gran numero di maschere con cui si riveste. Per esempio, la dualità che distingue il soggettivo dall’oggettivo si manifesta, in fisica, nel dilemma che riconosce alle particelle subatomiche una duplice natura, corpuscolare e ondulatoria: nella prima, ciascuna di esse ci appare come un oggetto indipendente, nella seconda come una microscopica porzione di arazzo.
Quanto più la scienza moderna sta andando a fondo nella decifrazione dei codici attraverso i quali l’arazzo si esprime, tanto più capita con frequenza di imbattersi in spiegazioni contraddittorie, ma vere entrambe.
Così è per corpuscolare-ondulatorio o soggettivo-oggettivo: dualismi diversi ma sostanzialmente uguali, che denotano la capacità di combinare i propri termini in modi infiniti, così come l’arazzo modifica all’infinito lo spaziotempo.
Se fossimo in grado di conciliare pienamente il soggettivo e l’oggettivo, svanirebbe la sensazione di separatività che avvertiamo nei confronti delle forme da noi percepite.
È questa la fonte di innumerevoli errori, riassumibili nell’idea che la realtà sia costituita da oggetti esterni a noi; e questa illusione ne genera un’altra ancora più onnicomprensiva, quella dell’esistenza oggettiva dello spaziotempo.
Se non ne fossimo vittima, scopriremmo che non solo non sappiamo cosa ci sia al di fuori di noi, ma neanche, a rigor di termini, se ci sia qualcosa; ed anzi, il fatto che un singolo punto dell’arazzo sia in grado di contenerne tutte le informazioni, farebbe proprio supporre che al di là di quel punto non ci sia niente.
Il problema è che esso contiene un numero di informazioni incalcolabilmente maggiore di quante il nostro sistema neuronale ne possa riordinare.
Tutto quello che conosciamo è la realtà passata al filtro della nostra visione individuale, non la realtà stessa.
La quantità di informazioni codificabili varia molto da persona a persona, ma comune a tutti è il modello di cui ci serviamo per interpretarle: creare nella nostra mente mappe che raffigurano il territorio - specchi della realtà forzatamente parziali, ma il più possibile estesi.
È questo un sistema che - pur coi suoi limiti - soddisfa le nostre esigenze, grazie al fatto che tutti abbiamo una visione comune dello spazio (molto meno soggettiva di quella che abbiamo del tempo): un metro è un metro sia nella nostra mente che nel mondo esterno, e concordando su questa prospettiva tutti gli esseri umani diventano ermetisti, e ciascuno applica il Come in alto, così in basso a modo suo.
Insomma, il nostro cervello è una macchina in grado di replicare le leggi dell’arazzo su scala ridotta.
L’abbiamo costruita lentamente, lungo l’arco di milioni di anni, e non ci siamo riusciti transitando attraverso un processo consapevole: semplicemente, l’evoluzione ha privilegiato gli esseri umani che giungevano casualmente a migliorare il processo di replicazione, attraverso lo sviluppo di cervelli provvisti di sistemi neuronali più estesi, e di neuroni in grado di svolgere meglio e più in fretta il proprio compito di condurre le informazioni.
Più che la scienza, è vicina a questi fenomeni la tecnica di meditazione tibetana del mahamudra, che consiste nel risalire le informazioni esperienziali fino a identificarne l’origine.
Ora, volendo definire in sintesi - ed in forma generalizzata - l’aumento delle capacità di interconnessione neuronale degli esseri umani, possiamo dire che essa equivale ad un aumento della nostra capacità di eseguire procedure complesse.
È quindi da considerare un passo fondamentale dell’evoluzione l’ingresso nel linguaggio corrente del termine algoritmo, che è il modo per definire questa capacità; e se volessimo darne una definizione più estesa, potremmo aggiungere che l’algoritmo - inteso come standardizzazione di una procedura - opera mediante l’attingere i propri elementi da varie fonti, fornendo ancora un’altra importante replica microcosmica delle procedure dell’arazzo.
L’applicazione degli algoritmi non tanto al campo dell’informatica, quanto a quello del funzionamento cerebrale (i neuro-algoritmi) contribuisce a individuare i meccanismi comuni al pensiero, alla concettualizzazione, all’espressione verbale, alla filosofia, alla matematica.
In questo modo, l’umanità sta trasferendo nella realtà l’utopico sogno che fu eternato da Hermann Hesse nel Gioco delle perle di vetro.
Daniele Mansuino
Altri articoli sull'Esoterismo
Daniele Mansuino offre gratuitamente il suo Ebook:
Scaricalo nel formato PDF > 666
Libri pubblicati da Riflessioni.it
RIFLESSIONI SUL SENSO DELLA VITA 365 MOTIVI PER VIVERE |
|