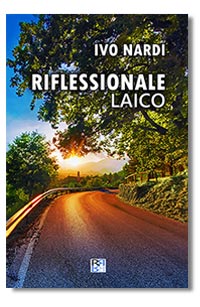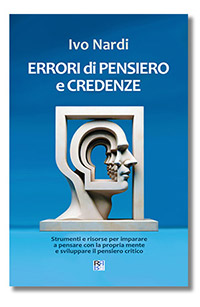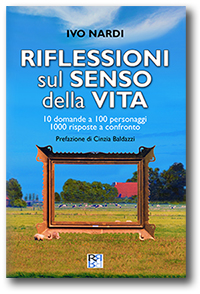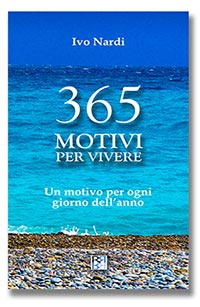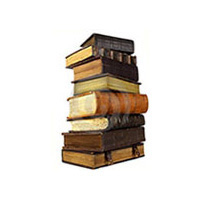
Riflessioni Filosofiche a cura di Carlo Vespa Indice
Sulla scena del crimine
di Marco Calzoli - Novembre 2025
La scena del crimine è il luogo in cui si consuma il delitto. È fondamentale nelle indagini. Tutte le investigazioni criminali si basano su due aspetti:
- Le tracce presenti sugli individui collegati al reato (vittima, offender);
- Le tracce presenti sugli strumenti o sugli oggetti che l’offender ha utilizzato o toccato durante la commissione del crimine).
Secondo i teorici del FBI, la scena del crimine presenta tracce della personalità di chi compie il reato, ragion per cui dalla analisi della stessa è possibile risalire in qualche maniera ad alcune caratteristiche psicologiche e personologiche dell’offender. Questo si compie mediante il criminal profiling, tecnica che nasce attorno agli anni Sessanta dello scorso secolo in seno al FBI per casi di presa di ostaggi, poi estesa anche a crimini seriali (oggi il criminal profiling è maggiormente applicato per questi reati).
Facciamo un esempio. Una scena del crimine caotica, con oggetti fuori posto, disordine, è indicativa di una mente criminale in sé disorganizzata, che riflette all’esterno questa sua caratteristica. Una mente disorganizzata è per esempio quella di uno schizofrenico (disturbo qualitativo). Al contrario, una scena del crimine ordinata è indice di una mente criminale organizzata, come uno psicopatico (disturbo quantitativo) oppure un professionista.
Il criminal profiling non entra nel processo, ma serve unicamente ad indirizzare le indagini.
Il profiler è uno psicologo esperto nella analisi del comportamento. Egli stila delle caratteristiche personologiche utili alle indagini. Non si tratta di una scienza esatta, ma di indicazioni che potrebbero risultare vincenti quando gli strumenti tradizionali in mano agli investigatori non possono essere usati. Per esempio, non ci sono testimonianze o immagini di telecamere, non ci sono impronte digitali, non c’è l’arma del delitto. Per risolvere un caso di omicidio è tradizionalmente necessario avere in possesso almeno uno di questi tre elementi:
- Una confessione;
- Un testimone;
- Una prova materiale (l’arma del delitto, una impronta digitale).
In assenza di tutto questo, il profiler della polizia tenta di risalire in qualche maniera all’offender mediante l’analisi della scena del crimine.
Secondo il principio di Locard, quando un corpo entra in contatto con un altro corpo lascia sempre delle tracce. Ma non è sempre possibile trovarle.
La teoria classica del FBI è che non ogni azione sulla scena del crimine (criminal pattern) possa essere ricostruita dalla sua analisi, ma almeno le più importanti ai fini del delitto.
L’inizio del criminal profiling nell’ambito delle indagini della polizia, lo abbiamo con il caso Mad Bomber. Dal 1940 e per quasi un decennio, un pazzo dinamitardo metteva bombe a New York. La polizia brancolava nel buio, fino a quando non si rivolse allo psichiatra Jamers Brussel, il quale fece un profilo perfetto del presunto bomber. Sulle indicazioni di Brussel venne effettivamente arrestato nel 1957 un tale George Metesky, il quale rientrava perfettamente nelle caratteristiche ricostruite dallo psichiatra mediante l’analisi della scena del crimine.
Ma il vero e proprio incipit di questo metodo lo abbiamo con Howard Teten, a metà degli anni Sessanta, padre indiscusso della analisi comportamentale della scena del crimine. Egli con l’aiuto dello psicologo Pat Mullany, mette a punto un metodo più sistematico rispetto al modello di profiling usato da Brussel. Quest’ultimo analizzava lo stato mentale dell’autore ignoto del crimine per poi rapportarlo alla scena del crimine. Invece Teten ebbe l’idea di partire dalla analisi della scena, generando poi le inferenze comportamentali.
È grazie a Teten e a Mullany che il FBI è stato la prima forza investigativa ad applicare le tecniche del profilo criminale in supporto alle indagini della polizia in particolari reati di grande efferatezza, senza apparente movente e/o con caratteristiche di serialità.
Nel 1978 il FBI crea formalmente uno stabile programma di sviluppo ed analisi denominato Psychological Profiling Program, creato dalla neonata Behavioral Science Unit, che da quel momento sarà in pianta stabile nell’organico del FBI Academy di Quantico.
L’agente speciale John Douglas entra nel FBI nel 1970, mentre nel 1977 viene trasferito al Behavioral Scienze Unit dove ha insegnato negoziazione ostaggi e psicologia criminale applicata. Ha creato e gestito il Criminal Profiling Program e per questo è stato promosso a capo del Investigative Support Unit, una divisione del FBI del National Center for the Analysis of Violent Crime.
Nelle strategie del profilo del FBI il contributo di Douglas, Ressler, Burgess e Hartman rappresenta ancora oggi la base contenutistica più diffusa. Questi autori hanno suddiviso la tecnica del criminal profiling in almeno cinque fasi:
- Profiling input: raccolta di tutti i dati sulla scena del crimine (tracce, informazioni sulla vittima come le abitudini, la struttura familiare, l’ultimo avvistamento, età, …);
- Decision process model: analisi delle informazioni per rispondere a domande del tipo “che crimine è stato commesso?”, “qual è il movente primario?”, “qual è il livello di rischio cui era soggetta la vittima?”, “quanto tempo ha trascorso l’offender sulla scena del crimine?”, e così via;
- Crime assessment: ricostruzione del comportamento dell’offender nella sequenza degli eventi del crimine;
- Criminal profiling: descrizione tipologica del sospettato;
- Investigation: viene stilato un rapporto scritto consegnato agli investigatori per cercare preferibilmente un sospetto che abbia quelle caratteristiche.
Il FBI osserva che sulla scena del crimine ci possano essere queste tipologie di comportamento:
- Modus operandi: azioni e attività che l’offender ha messo in atto nel commettere il delitto. I crimini violenti si originano dalle fantasie dell’offender; più egli fantastica maggiore diventa la necessità di esprimere queste fantasie. Quando passa all’azione (acting out), può mostrare, in alcuni aspetti del crimine, queste fantasie uniche e personali. Si parla di Personification in relazione al fatto che l’offender mostra comportamenti originali, che vanno al di là della mera necessità di commettere il crimine (per esempio spogliare la vittima assassinata). Solo l’offender conosce il reale significato di questi comportamenti ritualistici. Se l’offender reitera il reato e agisce ancora questa personificazione, si parla di
- Signature: è la firma psicologica. Si tratta di comportamenti stabili e ripetitivi che non hanno alcuna funzione nella buona riuscita del crimine ma che riflettono un bisogno psicologico del soggetto. Per esempio il mostro di Firenze pettinava le vittime dopo l’omicidio.
- Si parla invece di Undoing per quella personificazione basata su ragioni più ovvie. Viene infatti messa in atto frequentemente quando c’è una stretta relazione tra vittima e offender o quando la vittima rappresenta qualcosa di significativo per lui. Per esempio, coprire il viso della vittima, nascondere il corpo, e così via.
- Overkilling: colpire la vittima oltre la necessità di ucciderla, come il killer che infligge decine di coltellate o spara tutto il caricatore in preda alla furia omicida. L’overkilling concentrato sul volto della vittima esprime volontà di depersonalizzazione (simbolicamente l’aggressione si concentra sulla zona degli occhi perché lo sguardo della vittima è l’elemento principale che fa ricordare all’assassino di avere una persona di fronte.
- Staging: è la “messa in scena”, cioè quando c’è una alterazione volontaria della scena del crimine prima dell’arrivo della polizia, per esempio per depistare le indagini. Lo Staging, “messa in scena”, non va confuso con il Posing, “messa in posa”: il primo serve a depistare le indagini, il secondo è riconducibile alla firma psicologica.
Un noto adagio diffuso tra i profiler del FBI recita: “Quando il Come e il Perché di un dato evento criminale sono stati chiariti … di lì a poco verrà anche il Chi (ha commesso quel crimine)”.
Il Modello Anglosassone o Modello di Liverpool, invece, è stato elaborato da Canter e Hodge nel 1997 e, a differenza del modello precedente, basa la stesura del profilo su cinque fattori fondamentali:
- Coerenza interpersonale: l’aggressore si relaziona alla vittima con modalità analoghe a quelle utilizzate con le altre persone nella sua vita quotidiana;
- Ruolo del tempo e del luogo del delitto: queste due variabili sono spesso una scelta consapevole del criminale. Caratteristiche del crimine: le modalità di esecuzione e le peculiarità della scena vengono usate per individuare a quale categoria l’aggressore appartiene ovvero organizzato o disorganizzato;
- Carriera criminale: l’esordio precoce di azioni criminali è il maggior predittore di una lunga e persistente carriera criminale;
- Conoscenza sulle tecniche di investigazione: attraverso l’analisi di ogni elemento, si cerca di capire se l’aggressore abbia o meno delle conoscenze sulle tecniche investigative. Il maggior punto di forza di quest’approccio consiste nell’uso di procedure statistiche e nel costante confronto empirico delle ipotesi, finalizzato allo sviluppo di un modello scientifico di profilo criminale.
- Inoltre, alle categorie organizzato/disorganizzato dell’approccio dell’FBI spesso tra loro sovrapponibili, Canter e la propria equipe propongono la classificazione dicotomica espressivo/strumentale, sulla base delle motivazioni intrinseche che spingono il criminale a compiere l’azione delittuosa (la motivazione espressiva è causata da frustrazione, rivendicazione, psicopatologia; quella strumentale da tornaconto personale.
In criminologia, la "reciprocità letale" (o "interrelazione") si riferisce all'analisi di come gli elementi isolati nella scena del crimine, i movimenti dell'assassino e della vittima, e le relazioni tra loro possano essere collegati per comprendere le motivazioni del crimine, in particolare in caso di serial killer. In sostanza, si tratta di analizzare la scena del crimine come un insieme interconnesso per comprendere meglio il modus operandi dell'assassino e il perché ha scelto quella particolare vittima. Gli analisti della scena del crimine, infatti, studiano anche le caratteristiche della vittima: perché è stata scelta proprio lei? Cosa ha attirato il killer?
Si stima che in Italia ci siano 40 serial killer in libertà. La difficoltà a collegare allo stesso killer omicidi all’apparenza isolati si chiama “cecità di collegamento”, deriva anche da una mancanza di corretta comunicazione tra le varie forze di polizia. La “linkage analysis” è quel processo necessario per determinare se esistono connessioni o fattori comportamentali distintivi in comune tra due o più casi precedentemente non correlati.
Secondo la maggior parte degli studiosi mondiali, sono dodici i fattori predittivi di un serial killer, cioè che indicano se una persona è predisposta a compiere delitti seriali (vale a dire più di due vittime con un intervallo emotivo da un omicidio all’altro e senza motivazioni “normali”, come interesse economico):
- Isolamento sociale durante l’infanzia;
- Difficoltà di apprendimento;
- Sintomi di danno neurologico (qualche autore ha ipotizzato che si diventa serial killer a causa di traumatismi alla testa);
- Comportamento irregolare (bisogno di mentire, ipocondria, abitudini camaleontiche);
- Problemi con l’autorità e di autocontrollo;
- Visione precoce di materiale pornografico;
- Attività sessuale precoce e bizzarra;
- Ossessione precoce per il fuoco, il sangue e la morte;
- Crudeltà verso animali o altre persone;
- Precedenti di furto;
- Comportamento autodistruttivo;
- Precoce abuso di stupefacenti.
Con l’enorme sviluppo della scienza e della tecnologia degli ultimi anni è cambiato anche il ruolo della prova nel processo penale. Una volta la prova era detta dichiarativa (specifica), cioè era basata sulle testimonianze e sulle argomentazioni. Oggi la prova molte volte è scientifica, la quale suppone il passaggio dalla argomentazione alla informazione.
I principi della prova scientifica in un processo penale sono essenzialmente due:
- Principio di Frye: la prova scientifica deve essere accettata dal giudice solo se abbia raggiunto una generale accettazione nel settore scientifico cui appartiene;
- Principio di Daubert: è sempre il giudice che deve stabile se la testimonianza proposta da un esperto sia nel contempo rilevante e affidabile, perciò ammissibile.
Questi principi passano da un minimo a un massimo. Una perizia psichiatrica è molto opinabile, può cambiare drasticamente da un esperto all’altro, mentre il DNA ha una certezza quasi assoluta, ma mai assoluta al 100%. Ricordiamo che la scienza è sempre un prodotto dell’uomo, quindi è per natura perfettibile, mai perfetta. Per questo la testimonianza di ogni esperto va sempre valutata dal giudice.
Anche la medicina legale serba delle incognite. Ci sono stati casi giudiziari in cui anche la data della morte stabilita da due medici legali diversi risultò assai divergente: un medico indicò il decesso poche ore prima del ritrovamento del cadavere, mentre l’altro ventun giorni dal ritrovamento. L’art. 348 del Codice di Procedura Penale prevede che la polizia giudiziaria può convocare un medico quando questa compie indagini dirette ad assicurare le fonti di prova e questo professionista “non può rifiutare la propria opera”. Il testo dell’articolo prevede un medico in genere, anche se non specialista in medicina legale, e per di più questi non può esimersi dal fare il referto. Bisogna osservare che non tutti i medici posseggono la adeguata competenza per stabilire l’ora del decesso o per preservare, analizzare tutte le fonti di prova sulla scena del crimine. Nei piccoli centri la polizia giudiziaria può convocare un medico qualsiasi, come un pediatra, un cardiologo. Nei centri più grandi c’è l’Istituto di medicina legale e quindi l’autorità chiama un medico legale, ma anche in questo caso non tutti i medici legali hanno la necessaria competenza. Molti processi sono stati ribaltati da esperti che hanno proprio attaccato la consulenza del medico chiamato dall’autorità, il quale non la fece con i dovuti criteri.
L’enorme potenziale delle tracce fisiche (quella che dà più informazioni è il sangue) può essere compreso solo attraverso la comprensione di questi elementi:
- Di che tipo di traccia si tratta;
- Come va raccolta e preservata;
- Come determinare il tipo di informazioni che si possono ottenere a partire dalla traccia;
- Come interpretare quelle informazioni nel contesto generale.
È chiaro che se abbiamo una traccia molto importante ma il medico legale o l’operatore della polizia giudiziaria non repertano nella giusta maniera oppure non la conservano in modo idoneo, quella traccia perde di importanza. Per esempio, se prima della analisi delle impronte digitali dell’assassino su un portafogli, questo viene conservato male e ci cresce la muffa, le impronte non possono essere rilevate.
Il comportamento umano si basa su questi elementi:
- Logica iniziale: serve a raggiungere lo scopo, è un programma ideale su come si deve svolgere l’azione;
- Personalità: determina la scelta dell’obiettivo specifico e lo stile di raggiungimento dello scopo;
- Psicopatologia: stile e intensità dell’azione, connotazione emotiva;
- Fattori contestuali: problemi imprevisti che dipendono dal fatto che il progetto ideale (logica iniziale) si deve scontrare con la realtà dei fatti;
- Logica secondaria: per risolvere gli imprevisti e raggiungere lo scopo, il soggetto si adatta, compie monitoraggio dell’azione e cambia indirizzo del comportamento.
Pertanto la traccia si produce mediante questo iter: l’offender si propone uno scopo, quindi adotta una logica iniziale, allora nel commettere il crimine sorgono variabili impreviste determinate dal contesto, per questo il killer applica una logica secondaria che modifica l’azione criminale, che si attua producendo la traccia.
In Italia esistono prove legali (come il giuramento, che è regolamentato dalla legge e deve essere accettato dal giudice) e prove non regolamentate dalla legge, le quali il giudice è libero o meno di accogliere ex art. 189 del Codice di Procedura Penale.
Il Forensic Scienze Advisory Council è una struttura che parte dai principi della prova scientifica (Frye, Daubert) e vede affiancati magistrati, scienziati e operatori della polizia criminale al fine di redigere protocolli per la validazione delle prove e delle tecniche scientifico-forensi.
La criminalistica è lo studio scientifico delle tracce sulla scena del crimine. La criminologia è lo studio multidisciplinare del reato, del reo e della vittima (analisi psicologica dell’offender, dati statistici relativi alla diffusione dei reati in una certa zona, e così via). La investigazione è l’insieme delle tecniche logiche (deduzione, induzione, abduzione) che, sulla base degli elementi scientifici (criminalistica) e degli elementi psicologici e sociologici (criminologia) relativi a un dato crimine e a un dato reo, portano alla sua identificazione e cattura.
Riguardo una prova non regolamentata dalla legge: in forza dell’art. 187 il giudice può assumerla se è idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti; in forza dell’art. 642 il giudice la assume se non pregiudica la libertà morale della persona (per questo in Italia non si accetta il siero della verità o narcoanalisi).
L’ENFSI (European Network Forensic Science Institute) è un organismo internazionale che racchiude al suo interno i più importanti istituti di scienze forensi a livello europeo. Nel 2009 la Commissione Europea lo ha riconosciuto come organo Monopolista, cioè l’unica voce della comunità scientifica forense in Europa. Esso ha il compito di garantire la qualità delle analisi tecnico-scientifiche in tutta Europa.
Si parla di Cold Case in riferimento a un evento delittuoso che all’epoca dei fatti non è stato risolto e quindi archiviato. Ciò vale anche per le persone scomparse il cui corpo non verrà mai ritrovato, nei confronti delle quali viene aperto un procedimento penale per omicidio verso ignoti, questo permette alla Procura di eseguire delle investigazioni che hanno una capacità di penetrazione maggiore.
Grazie a nuovi fronti investigativi, ulteriori prove oppure tecnologie che permettano analisi migliori delle prove già esistenti si riapre il caso tentando una soluzione. In un caso irrisolto abbiamo quattro elementi:
- Comunicazione notizia di reato (solo se il decesso è stato archiviato come crimine);
- Informazioni sommarie;
- Perizie;
- Consulenze tecniche.
L’investigatore deve portare alla autorità giudiziaria nuovi elementi, basandosi su un vaglio motivato di questi quattro elementi.
Abbiamo anche la Morte Equivoca, come nei casi di apparente suicidio. Per tale eventualità si applica la Autopsia psicologica, che nasce nei primi anni Sessanta negli Stati Uniti (Shneidman et alii), in ambito clinico, per iniziativa del Los Angeles Suicide Prevention Center, come risposta alla crescente necessità di capire meglio le cause psicologiche sottese ai suicidi. Il metodo, inizialmente centrato su finalità preventive, si è successivamente affermato anche in ambito forense e criminologico come mezzo per chiarire la natura di decessi in condizioni non univoche. In pratica si percorre la storia della vittima fino al decesso per appurare se la morte sia compatibile con un quadro psicologico suicidiario o meno. Per esempio presa in esame di lettere del deceduto con l’intenzione di suicidarsi, certificati medici di depressione, abitudini varie, e così via. Per inciso, ricordiamo che i suicidi lasciano un biglietto solo nel 15% dei casi.
L’obiettivo principale è stabilire se il decesso possa essere ricondotto a un suicidio, a un incidente, a una morte naturale o a un evento procurato da terzi. Secondo Leenaars, il metodo si basa sull’assunto che il comportamento suicidiario sia il risultato di una confluenza di fattori psicologici, biologici, ambientali e culturali. L’autopsia psicologica cerca di ricostruire questi fattori ex post, integrando narrazioni soggettive, elementi clinici e dati oggettivi.
L’autopsia psicologica è una procedura tecnica di considerevole importanza nel caso in cui non sia possibile ricondurre con certezza la morte di un individuo ad un chiaro intento autolesivo e quando le informazioni di matrice medico-legale non consentono di arrivare in maniera certa a conclusioni definitive.
Si delinea il profilo psicologico della vittima analizzando i fattori di vulnerabilità e la psicologia del presunto suicida.
La suicidologia nasce con Shneideman nel 1949. Egli inizia a studiare la psicologia del suicida con l’analisi della mente di una persona che scrive un biglietto per suicidarsi e quella di una persona che scrive un biglietto senza l’intenzione di ucciderci. Egli ravvisò nel primo caso il cosiddetto Psycache, cioè quel dolore profondo che spinge al gesto estremo. Per lo studioso il suicidio non è un atto verso la morte ma un allontanamento dalla vita, cioè una forma di liberazione da questo dolore insopportabile. Per questo il suicida di solito non dimostra di avere progetti a lungo termine.
Il suicidio è un evento unico, in quanto la persona è sempre una entità unica. Pertanto chi studia la psicologia di un suicida sa che non deve giudicare il gesto secondo le proprie categorie, ma secondo quelle di quel soggetto che lo ha compiuto. Inoltre nessun fattore singolo della vita di una persona è necessario e sufficiente per il suicidio, ma c’è sempre un insieme di più motivi o fattori.
Le fonti principali di dolore psicologico sono:
- Vergogna
- Rabbia
- Colpa solitudine
- Disperazione
- Quello che origina da bisogni negati e frustrati.
L’autopsia psicologica cerca di appurare, da tutti questi elementi, alcuni indici di suicidabilità, facendo propendere o meno verso la ipotesi suicidiaria.
Una rivisitazione e un ampliamento del principio di Locard postulano questo:
- Il reo lascia tracce sulla scena del crimine;
- La scena del crimine lascia tracce sul reo;
- Il reo lascia tracce sulla vittima;
- La vittima lascia tracce sul reo.
Nella autopsia psicologica è possibile inferire, con un certo grado di probabilità, se la vittima e il reo siano lo stesso soggetto o meno. Nel primo caso, questo metodo permette la raccolta di molti fattori e di molte tracce, comunque statisticamente di più rispetto a un caso di omicidio.
In ogni caso, la autopsia psicologica non è molto frequente in quanto spesso il medico legale riesce a capire, mediante l’analisi del cadavere o altro, se si tratta di suicidio oppure di un omicidio.
Facciamo il caso di un soggetto morto perché avvelenato e poi buttato in acqua dal killer per fingere un annegamento volontario. Ci sono segni caratteristici dell’annegamento, che il medico può appurare. Nei polmoni dilatati può esserci la presenza di liquido spumoso, mentre nei bronchi di muco viscoso. Il ventricolo sinistro del cuore è generalmente vuoto, mentre quello destro è dilatato. Presenza di piccole emorragie toraciche. Si può constatare una differenza elettrolitica tra i due ventricoli del cuore. Raramente compaiono sulla superficie polmonare le macchie di Tardieu e le macchie di Paltauf. Nell’annegamento in acqua dolce si verifica generalmente diluizione del sangue ed emolisi, dovute al passaggio nel torrente circolatorio del liquido annegante ipotonico penetrato a livello polmonare; per questa ragione il sangue del ventricolo sinistro, refluso dai polmoni, ha una diluizione maggiore rispetto a quello del ventricolo destro. La cloruremia risulta variare rispetto al valore normale, diminuendo o aumentando rispettivamente a seconda dell’annegamento in acqua dolce o salata. Il ferro ematico totale risulta ridotto nella cavità cardiaca sinistra rispetto a quella destra. Aumenta lo stronzio ematico.
Oppure prendiamo il caso di una persona ritrovata impiccata, che però è stata uccisa in altro modo e il killer ha finto il suicidio per impiccagione. Anche in questo caso il medico legale può appurare segni specifici. Di solito nelle asfissie compare cianosi del volto (per via del fatto che il sangue non riceve ossigeno) e petecchie, soprattutto sottocongiuntivali (si rompono i vasi capillari per lo sforzo di respirare nonostante l’ostruzione). Invece nell’impiccamento, a causa della frequente e intensa compressione arteriosa, tendono a venire meno la cianosi e le petecchie. La lesione cutanea dovuta al laccio sul collo è presente a forma di V (e non parallela, che invece compare quando il killer per esempio usa un laccio da dietro con il soggetto in piedi, in questo caso si parla di strangolamento). In 11 casi su 17 l’impiccamento si accompagna a emorragie puntiformi delle cartilagini intervertebrali, generalmente in sede lombare (diversamente dalla semplice sospensione di cadavere).
Lo strozzamento si compie con due mani attorno al collo. Compare sulla cute del collo la ecchimosi dovuta alle mani del killer, può esserci il segno delle unghie del killer sul collo. Dello strozzamento sono rappresentative le infiltrazioni ematiche dei fasci muscolari.
Mettiamo anche il caso del killer che inscena un suicidio con taglio delle vene dei polsi per nascondere la morte asfittica provocata. In questi casi occorre osservare che un cadavere, a cui sono recise le vene, non sanguina (il sanguinamento è prodotto dalla pressione arteriosa, che nel decesso viene meno). Segni generali indicativi di una morte per asfissia sono: enfisema polmonare acuto, petecchie emorragiche, dilatazione della sezione destra del cuore, stasi sanguigna nel territorio destro del cuore, stasi sanguigna viscerale diffusa associata ad anemia splenica, sangue scuro e fluido (nessuno di questi segni interni è specificatamente associato in maniera assoluta alla morte asfittica, nemmeno presi insieme. Tuttavia la presenza dei segni esterni e la mancanza di altre specifiche condizioni patologiche, assieme a tali segni interni, fanno propendere con buona probabilità verso la diagnosi di morte asfittica). Tra i segni esterni ricordiamo: cianosi del volto, petecchie, fungo schiumoso a livello degli orifizi respiratori. A volte compaiono i “denti rosa” (a causa della diffusione nei tubuli del sangue pulpare). Negli esami di laboratorio si valuta la presenza di alterazioni nell'equilibrio acido-base, che possono indicare ipercapnia (accumulo di anidride carbonica) e anossiemia (mancanza di ossigeno). L’analisi dell'umor vitreo può fornire informazioni sulla composizione del liquido all'interno dell'occhio e aiutare a determinare il tempo di morte, soprattutto se c'è una differenza significativa tra l'umor vitreo e il sangue. L'umor vitreo, infatti, contiene anche gas, come l'ossigeno, l'azoto e l'anidride carbonica. I livelli di questi gas possono essere analizzati per determinare se la morte è avvenuta per asfissia e, in particolare, il tipo di asfissia (ad esempio, annegamento o strangolamento). Menzioniamo in merito una interessante ricerca dell’Università la Sapienza di Roma (Cecchi et alii 2013) che propone l’impiego di un nuovo marcatore, rilevabile nel tessuto polmonare, in grado di contribuire alla diagnosi differenziale di asfissia meccanica. Se questo studio verrà dimostrato, porterà a un test specifico per diagnosticare la morte asfittica.
In caso di ferita da arma bianca il medico legale apprezza la direzione del taglio per capire se è stato provocato dallo stesso soggetto nel suicidio oppure da altra angolatura dall’assassino. Nelle ferite da punta in genere il suicida si colpisce al cuore denudandosi il petto.
La diagnosi fra ferite lineari (da taglio) causate in vita o dopo la morte, specie per ferite superficiali, è talvolta difficile a causa della scarsa infiltrazione sanguigna dei margini della lesione, perché il sangue scorre via dai tessuti privi di anfrattuosità. L'omicidio ed il suicidio si distinguono per la diversa sede delle lesioni: sono sedi di elezione nel suicidio i polsi, la piega del gomito, il collo del piede; nell'omicidio l'aggressore colpisce come e dove può, le ferite hanno sedi, direzioni e profondità le più diverse ed accanto alle lesioni di organi vitali si possono rinvenire le ferite da difesa agli arti superiori e da schivamento al dorso ed alle spalle; sede frequente per entrambi i casi è il collo (scannamento o sgozzamento); caratteristica del suicidio è la ripetizione di molte ferite nello stesso punto parallele o confluenti.
Il numero dei colpi può essere molteplice anche nel suicidio, ma risultano tutti ravvicinati, nell'omicidio il numero di colpi è talora assurdo, alcuni possono essere raggruppati, segno di un rapido susseguirsi di colpi senza cambiamento di posizione tra aggressore e vittima, ma non mancano i colpi anche lontani. Tranne casi eccezionali, la molteplicità delle ferite è invece in contrasto con l'accidentalità. La direzione dei colpi è in genere la stessa nel suicidio, costantemente cambiata nell'omicidio.
Invece le differenze tra suicidio e omicidio con arma da fuoco sono:
- Suicidio: arma vicino alla vittima o nella mano (ma potrebbe essere un depistaggio da parte dell’omicida);
- Suicidio: se la zona attinta dal proiettile è tempia, cuore, bocca, mento, fronte, cioè organi comunemente considerati vitali. Ma anche l’omicida può colpire punti vitali, la differenza tra un omicida professionista e uno che non lo è si vede dalla quantità di colpi e dalle zone attinte: il professionista uccide con meno colpi possibili, sparati di solito con il calibro più grande che sa maneggiare, nelle zone vitali, specie cuore, colonna vertebrale e testa, particolarmente da dietro, o, sempre da dietro, i due polmoni, mentre l’omicida in preda ad un raptus per esempio o che non è esperto di medicina nera (quell’insieme di metodiche sul corpo umano opposte a quelle adottate da un medico per salvare la vita) cerca di sparare più colpi possibili in zone scelte a caso. Invece il professionista sa che non ha senso crivellare una persona di colpi per uccidere, ma deve colpire i punti vitali. Il professionista che ha un solo colpo a disposizione attinge testa o cuore. Bisogna anche dire che chi uccide e vuole uccidere con professionalità cerca sempre di dare il colpo di grazia, quindi un professionista sparerebbe ad esempio all’addome, zona non altamente vitale come le altre, solo per avere sotto controllo il bersaglio da neutralizzare, colpendo in un punto facilmente raggiungibile, poi, quando la vittima è in balia del killer, darebbe un colpo di grazia alla testa per completare il lavoro. I killer professionisti, che fanno omicidi su commissione, sono presenti tanto nelle organizzazioni criminali quanto nei servizi segreti di molti stati: dato che i servizi segreti sanno fare ottimi depistaggi, i loro killer non uccidono solo in modo efficace e in maniera da non farsi prendere, ma anche in modo tale da sviare le indagini, per esempio facendo finta che un omicidio premeditato sia opera di un pazzo in preda a un raptus, e cioè disorganizzando la scena del crimine, per esempio sparando decine di colpi;
- Suicidio: in letteratura è segnalata la possibilità che la zona attinta sia inusuale, ad esempio la regione occipitale, così come avvenuto per il suicidio collettivo di alcuni componenti del gruppo terroristico Baader-Meinhof (ottobre 1977-prigione di Stammheim, Germania);
- Suicidio: la distanza dello sparo è minima (ma anche l’omicida può sparare vicino o a contatto, in questo ultimo caso anche per attutire il rumore dello sparo);
- Suicido: denudamento della zona colpita;
- Suicido: un colpo solo, mentre più colpi fanno pensare a un omicidio;
- Suicidio: segno di Felc, che è quella piccola lesione tra pollice e indice che si ha quando la pelle viene premuta dal carrello della pistola (significa che il suicida ha sparato e con una pistola semiautomatica);
- Suicidio: affumicatura sul dorso della mano (ha lo stesso significato del segno di Felc, ma la pistola è a tamburo);
- Suicidio: se si è usato un fucile da caccia, potrebbero comparire aloni di affumicatura più o meno marcata a livello del I spazio interdigitale della mano che sorregge la canna dell’arma in prossimità del vivo di volata. Questo elemento assume tuttavia rilevanza solo nell’ambito di una valutazione globale, potendo infatti essere riferito anche a manovre difensive di afferramento da parte della vittima di un’arma impugnata da terzi;
- Suicidio: presenza di tracce di sangue (micro-spruzzi) sul dorso della mano (segno importantissimo), se invece è presente una colatura di sangue sulla mano è stata fatta sicuramente da terzi dopo la morte;
- Suicidio: presenza di residui dello sparo sulla mano del suicida;
- La direzione dei colpi è un elemento molto importante per capire se si tratta di omicidio o di suicidio: chi si spara sulla fronte per esempio punta l’arma con una traiettoria dal basso verso l’alto. Bisogna altresì dire che non è infrequente che il suicida esploda il colpo impugnando l’arma con una o due mani in modo da azionare il grilletto con il pollice ed in tal caso possono raggiungersi sedi e determinarsi traiettorie che potrebbero comunemente essere ritenute incompatibili con un colpo autoinferto;
- Di solito il suicida sceglie luoghi isolati.
La medicina legale su cadavere, nello specifico la lesività da arma da fuoco, dunque la balistica forense, è una delle branche della scienza forense, la cui storia ha origini lontane, rimandando al 1835, allorquando Alexandre Lacassagne (antropologo francese), per la prima volta, estrasse il proiettile dal corpo di una vittima uccisa in Inghilterra, utilizzandolo come prova di un delitto e sempre un medico legale, il prof. Balthazar, agli inizi del 1900 teorizzò l’identificazione dell’arma mediante lo studio dei reperti balistici.
La balistica è un ramo della fisica meccanica che studia il moto di un proiettile, in particolare quello lanciato da armi da fuoco. Si suddivide in balistica interna, che studia il moto del proiettile all'interno dell'arma, balistica esterna, che studia il moto nel volo, e balistica terminale, che studia l'impatto del proiettile sul bersaglio. La balistica forense è una branca della scienza forense che comprende le indagini rivolte alla ricostruzione degli accadimenti relativi ad un delitto in cui sia stato fatto uso di un'arma da fuoco, finalizzata alla definizione delle responsabilità ed alla comminazione della pena.
Vale la pena ricordare che l’autopsia in tema di lesioni da arma da fuoco è una tra le più complesse e difficili indagini autoptiche medico-legali perché necessita in modo particolare di uno specifico bagaglio di nozioni di base di ordine extrabiologico che consentano di percepire oltre l’immediatamente visibile e, in funzione di ciò, approfondire lo studio al tavolo settorio per operare le più idonee correlazioni tra agente balistico e lesività, identificandone antecedenti, cause, evoluzione ed effetti. Il medico legale deve avere una notevole esperienza nello specifico tema di patologia medico-legale, sufficienti nozioni di balistica forense e una disponibilità di tempo e di risorse strumentali ed umane forse superiori a quanto richiesto per altre forme di lesività.
In caso di presunta violenza sessuale, il medico esaminerà eventuali tracce biologiche dell’aggressione sul corpo e gli indumenti della vittima, per esempio quelle di sperma. Può accadere che, date le piccole dimensioni o a causa del particolare colore e consistenza del tessuto, le macchie di sperma si mimetizzino perfettamente con esso, passando inosservate all’occhio dell’esaminatore. Per tale motivo, tutti gli indumenti andranno esplorati alla luce di Wood, strumento che consentirà, illuminando la superficie, di identificare le macchie di sperma, facendole apparire di un colore azzurro.
A livello del collo e in regione mammaria è possibile reperire anche segni di suzione e tracce di morsi, elementi questi non sempre necessariamente indicativi di violenza sessuale, ma reperibili anche dopo atti sessuali consenzienti; ad essi quindi va attribuito un valore probatorio solo se accompagnati da altri segni di violenza ed armonizzanti con la tipologia della lesione che ne viene rappresentata. Tali elementi potranno essere completati con la ricerca di tracce biologiche (saliva) che nelle suddette sedi potrebbero essere presenti, oppure operando uno studio sulla eventuale morfologia delle tracce, in relazione alla compatibilità con l’arcata dentaria, che può averle determinate, ciò al fine di facilitare l’identificazione dell’aggressore.
Nella donna già deflorata molto più difficile, se non addirittura impossibile resta spesso la possibilità di valutare, in base alle sole modificazioni dell’imene, se sia stata o no oggetto di violenza sessuale, in virtù della mancanza di un quadro specifico. Nella donna che si dichiara vergine, è possibile stabilire se l’imene è stato deflorato recentemente o non recentemente. Nel primo caso ci sarà sanguinamento e infiltrazione dei margini. Ma, in ogni caso, anche in presunta vergine, il rapporto potrebbe essere stato consenziente. Bisogna altresì considerare che, in certi casi, è possibile che l’imene non si rompa alla prima penetrazione.
Specie tra i reati sessuali c’è rischio di false denunce (per le motivazioni più varie: dal ristabilire un adeguato concetto di sé colpevolizzando l’amante occasionale che è accusato di stupro, all’estorsione o alla vendetta). Per scoprire la falsità: il ritardo della denuncia è un forte indice di non veridicità; la maggior parte degli stupratori non comunica con la vittima, quindi può essere indizio di falsità se la presunta vittima racconta di aver sentito l’aggressore dopo il fatto (per esempio telefonate intimidatorie); gli aggressori sessuali di solito non fanno atti sessuali particolari; poche vittime di violenze sessuali subiscono lesioni fisiche (le lesioni fisiche sono tipiche del serial killer, o comunque dello psicopatico, il quale tra l’altro può compiere tutto un rito violento prima dell’uccisione; è segno che la vittima è stata colpita prima della morte il forte sanguinamento delle ferite, perché da morti non si sanguina; stesso discorso per le contusioni senza ecchimosi, perpetrate dopo la morte); per un minore, vale la regola che se un familiare non vuole farlo parlare da solo con l’autorità è probabile che non vuole correre il rischio che il minore dica la verità (i minori del resto andrebbero sempre interrogati da soli).
In caso di violenza sessuale spesso la finestra del bagno è un ovvio fronte di entrata e uscita. Se c’è stata effrazione, bisogna controllare la natura dello scasso per appurare se l’aggressore è destrimane o mancino. Occorre anche valutare i diversi oggetti che egli avrebbe potuto toccare o fare cadere, come bottiglie di shampoo. Rilevare le impronte latenti sotto la tavoletta del water. Ispezionare i lavandini del bagno e della cucina, sifoni compresi.
Bisogna controllare i detenuti che escono per permesso premio, i precedenti giudiziari per modus operandi o altre caratteristiche simili per autore, vittima, scena del crimine.
Motivazioni di ogni comportamento umano sono le fantasie, che si producono nella mente dietro gli stimoli più vari, in grado di solleticare bisogni fisiologici. Da ogni tipo di bisogno può nascere una fantasia che è possibile legare ad una situazione piacevole che, tramite l’eccitazione neurovegetativa, spinge per essere messa in atto. L’offender (stupratore e killer) ha fantasie talmente potenti che non riesce a tenere relegate nella mente e quindi a gestire, agendole nella realtà solo quando è consentito. Hanno un carattere così intrusivo che, per lui, la maggiore gratificazione sta nello stupro oppure nell’omicidio, cioè nella messa in atto compulsiva di tali vissuti interiori.
Per “omicidio sessuale” si intendono queste categorie (secondo Berg):
- Omicidio involontario commesso durante atti sessuali;
- Omicidio commesso per consentire atti sessuali;
- Omicidio commesso dopo un delitto sessuale, come lo stupro, per assicurarsi l’impunità;
- Omicidio premeditato attuato per vari motivi ed accompagnato da atti sessuali;
- Omicidio come culmine sadico di atti sessuali;
- Omicidio come equivalente sadico di un atto sessuale.
Le ultime due categorie sono inquadrabili nel lustmurd (omicidio per libidine), cioè commesso per soddisfare in modo deviato, perverso un proprio bisogno sessuale. Il serial killer, secondo alcuni autori, sarebbe un praticante di lustmurd.
Nell’omicidio sessuale generalmente il soggetto uccide qualcuno con il preciso obiettivo di ottenere potere, controllo finalizzato all’ottenimento della gratificazione sessuale. Per i predatori di matrice sessuale il desiderio alimentato attraverso fantasie sessuali è principalmente quello di ottenere potere, controllo e completa sottomissione della vittima.
La letteratura tende a ricondurre la Firma Psicologica, relativamente ai predatori seriali, a una serie di episodi traumatici patiti durante la prima infanzia. È indubbio che esperienze precoci che hanno miscelato in maniera pericolosa sofferenza fisica o psicologica ed eccitazione sessuale siano alla base dell’operato della maggior parte degli assassini seriali studiati dalla letteratura criminologica internazionale.
Hickey (1997) ha elaborato un modello specifico per la genesi di un assassino sessuale individuando nel trauma la matrice principale in grado di spiegare e comprendere il passaggio all’atto da parte degli assassini seriali sessuali. Secondo Hickey esistono una serie di eventi traumatizzanti che hanno avuto luogo durante lo sviluppo infantile del futuro assassino e che hanno compromesso inevitabilmente lo sviluppo di una personalità armonica e adeguata fino a determinare l’inizio della serie criminale. Questo genere di eventi includono violenze fisiche, sessuali e psicologiche, l’assenza di uno o di entrambi i genitori, una situazione familiare caratterizzata da profonda instabilità. Le caratteristiche negative e disfunzionali di personalità maggiormente presenti negli assassini sessuali seriali secondo Hickey sono infatti la conseguenza dell’esposizione a tali scenari precoci e portano allo sviluppo di soggetti dotati di bassa autostima, socialmente inadeguati, contrassegnati da vissuti di impotenza e di profonda insicurezza. Le fantasie sessuali estreme diventano ben presto per questi soggetti l’unica via di fuga da una realtà che sperimentano come malevola, abusante e rifiutante.
Meloy (2004) distingue gli assassini sessuali in compulsivi (organizzati, pianificano dettagliatamente il crimine, sono antisociali o narcisisti) e catatimici (disorganizzati). Ricordiamo che il termine “catatimia” fu introdotto nel 1912 da Maier che lo utilizzò` per spiegare il contenuto dei deliri in alcuni soggetti psicotici. Successivamente fu ripreso da Wertham per spiegare gli atti di violenza estrema come gli omicidi. Meloy l’ha poi introdotto nella sua classificazione sui sexual homicide e successivamente è stato ripreso e rielaborato da Revitch e Schlesinger che, a loro volta, hanno aggiunto una ulteriore suddivisione tra omicidi catatimici acuti e cronici. In questa tipologia di assassino sessuale di Meloy abbiamo a che fare con un pattern motivazionale nel quale un conflitto sottostante crea un enorme accumulo di tensione psicologica nell’offender che viene liberata attraverso l’atto violento.
Invece lo stupratore avrebbe nella mente un desiderio sessuale perverso, talmente potente che diventa intrusivo e non gli permette di controllarsi. Però, secondo Orlandini, lo stupro non nascerebbe da un desiderio sessuale ma dal bisogno di dominio. Questo bisogno verrebbe conseguito attraverso la de-umanizzazione della vittima, che diventa un oggetto senza significato: la donna diventa il contenitore di tutte quelle emozioni negative di cui l’assalitore vuole sbarazzarsi, come se si trattasse di un’“infezione psichica”. Uno stupro ha veramente poco a che fare con la passione e la sessualità, è bensì un atto pseudo-sessuale dovuto ad ostilità, collera e controllo. Il bisogno, narcisistico e sado-masochistico, di esercitare la propria forza ed il proprio controllo su una vittima attraverso lo stupro, potrebbe derivare da sentimenti inconsci di impotenza e svalutazione, o da un profondo vuoto interno ed una profonda depressione. Anche secondo Groth, lo stupro è un “atto pseudo-sessuale”, nel quale il sesso è solo un veicolo per le principali motivazioni di potere e aggressione.
Dietz ha suddiviso il sex offender in due tipologie: situazionale (il più frequente, esercita il crimine per sfogare bisogni sessuali di base) e preferenziale (dalla intelligenza più elevata, il crimine è a servizio di vere e proprie perversioni sessuali o parafilie).
Invece Hazelwood, Warren e Burgess distinguono questi criminali in impulsivi (il più comune, dalla scarsa pianificazione del crimine) e ritualistici (pianifica dettagliatamente le modalità della aggressione, anche visitando più volte lo scenario prima dello stupro.
La donna sex offender può rientrare in una di queste quattro categorie: amante proibita (adesca un particolare adolescente e mette in atto condotte provocatorie e manipolative per ottenere il consenso all’atto sessuale), facilitatrice (la donna è parte attiva delle fantasie di un’altra persona), istigatrice (manifesta comportamenti di controllo e dominio sul minore fino ad arrivare ad aggredirlo sessualmente, in un quadro psicologico di elaborazione di una profonda rabbia), psicotica (affetta da grave forma di psicopatologia, perpetra il crimine soprattutto contro i figli o durante riti esoterici).
Secondo la nota definizione del FBI, il “serial killer” uccide più vittime per motivazione sadica e dopo un intervallo emotivo tra gli omicidi; il “mass murder” uccide più vittime nella stessa azione e nello stesso luogo; lo “spree killer” uccide più vittime nella stessa azione ma in luoghi diversi.
Di solito una persona uccide un suo simile quando proietta il proprio male sull’altro, intendendolo così quale causa del suo problema. Invece il serial killer uccide per il piacere di farlo.
Nonostante la varietà dei campioni e i diversi metodi utilizzati per costruire le tipologie, i ricercatori più recenti sono giunti a risultati simili, identificando costantemente due tipi principali di assassino sessuale: arrabbiato e sadico (Proulx). Esiste un terzo tipo di assassino sessuale che sembra uccidere per mettere a tacere l'unico testimone del crimine. Questo criminale sembra essere motivato principalmente dal bisogno di avere rapporti sessuali.
Poiché l'omicidio a sfondo sessuale è un atto di violenza estrema raro e poco compreso, si potrebbe essere tentati di concludere che molti dei suoi autori siano malati di mente. In effetti, alcuni autori ritengono che la maggior parte degli assassini a sfondo sessuale soffra di schizofrenia. Altri hanno suggerito disturbi dissociativi (Watkins) o disturbi ossessivo-compulsivi (Brown) come fattori contribuenti. Tuttavia, l'evidenza empirica sembra suggerire che la maggior parte degli assassini a sfondo sessuale non lo sia.
Senza una definizione chiara di omicidio sessuale, è molto difficile rispondere alla domanda se gli assassini sessuali differiscano dagli aggressori sessuali in generale. La ricerca sembra supportare l'affermazione che gli assassini sessuali e gli aggressori sessuali in generale (ma non i pedofili) siano, per la maggior parte, polimorfici quando si tratta di reati.
Marco Calzoli
Bibliografia
A. Aggrawal, Forensic and Medico-legal Aspects of Sexual Crimes and Unusual Sexual Practices, Abingdon 2009;
P. R. Arcuri, S. Caruso, Sangue del mio sangue, Cosenza 2021;
G. Bolino, Le indagini medico-legali sulla scena del crimine, Roma 2018;
G. Bolino, G. Umani Ronchi, Asfissie meccaniche violente, Milano 2006;
D. Canter, Criminal Shadows, New York 1994;
R. Cecchi et alii, “Markers of mechanical asphyxia: immunohistochemical study on autoptic lung tissues”, in International Journal of Legal Medicine, published online, 29 May 2013;
P. Dietz, R. Hazelwood, J. Warren, “The Criminal Behavior of the Serial Rapist”, in FBI Law Enforcement Bulletin, 1990;
J. Douglas et alii, Crime Classification Manual, Lexington 1992;
L. N. Eliopulos, Death Investigator’s Handbook, Boulder 1993;
G. Guadagnini, “Psicopatologia della sessualità”, in A. M. Casale, P. De Pasquali, M. S. Lembo (a cura di), Profili criminali e psicopatologia del reo, Santarcangelo di Romagna 2014, pp. 123-131;
R. Hazelwood, A. W. Burgess, Practical Aspects of Rape Investigation: A Multidisciplinary Approach, New York 2016;
R.M. Holmes, S.T. Holmes, Profiling Violent Crimes, Thousand Oaks 1996;
G. Iadecola, Medicina legale per l’attività di polizia giudiziaria, Roma 1998;
F. D. Jordan, Sex Crime Investigations, Roma 2008;
K. J. Kerr et alii, “Sexual homicide: Definition, motivation and comparison with other forms of sexual offending”, in Aggression and Violent Behavior Vol. 18, Issue 1 (Jan.-Feb. 2013), pp. 1-10;
C. Lavorino, Analisi investigativa sull’omicidio, Roma 2000;
C. Lavorino, Criminalistica, criminologia, investigazione, Roma 2004;
A. A. Leenaars, Suicide: A multidisciplinary issue, Abingdon 2002;
A. Orlandini, “Facing sexual violence in a rape emergency room: Identification, projective identification, and the myth of Nemesis”, in Journal of the American Academy of Psychoanalysis, Vol. 30.3 (2002), pp. 401-413;
C. Pomara, V. Fineschi, Manuale-atlante di tecnica autoptica forense, Padova 2007;
J. Proulx et alii, Sexual Murderers: A Comparative Analysis and New Perspectives, New York 2007;
R. K. Ressler et alii, Sexual Homicide, London 1988;
E. S. Shneideman, Suicide as Psychache: A Clinical Approach to Self-Destructive Behavior, New York 1993;
E. S. Shneidman, N. L. Farberow, R. E. Litman, “The psychological autopsy”, in American Journal of Psychiatry 118. 2 (1961), pp. 98-106;
F. Vinci et alii, Medicina legale e balistica forense, Roma 2020;
H. S. Wortzel, K. M. Bohnert, “A forensic psychiatric approach to the psychological autopsy”, in Journal of Psychiatry & Lay 38.2 (2010), pp. 239-257.
Marco Calzoli è nato a Todi, in Umbria, nel 1983. Prolifico poeta e saggista, ha dato alle stampe con varie Case Editrici 58 volumi. I suoi studi trattano di filosofia, psicologia, scienze umane, antropologia. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022.
Libri pubblicati da Riflessioni.it
RIFLESSIONI SUL SENSO DELLA VITA 365 MOTIVI PER VIVERE |
|