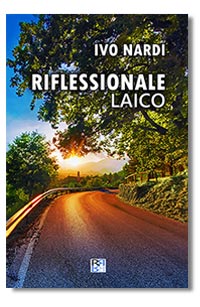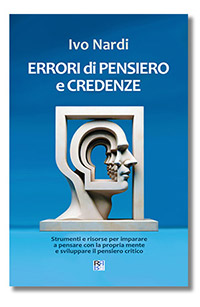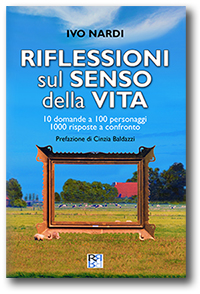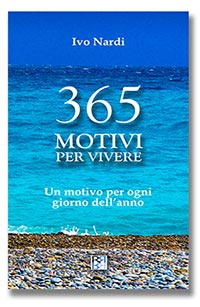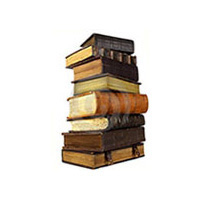
Riflessioni Filosofiche a cura di Carlo Vespa Indice
Su alcuni autori della tarda latinità
di Marco Calzoli - Ottobre 2025
Lucio Celio Firmiano Lattanzio nasce in Africa e sappiamo da Gerolamo che studia presso la scuola di Arnobio. Viene chiamato ad insegnare eloquenza latina da Diocleziano e in questo periodo fu un prolifico scrittore di diversi generi letterari. Abbiamo un Simposio, un Itinerario in esametri in cui tratta il viaggio dall’Africa a Nicomedia e si inserisce nel filone della poesia odeporica. In età matura si converte al cristianesimo, dopo l’editto persecutorio del 303 e deve lasciare l’insegnamento. Vive in clandestinità fino all’editto di Galerio e rimane poi a Treviri come precettore del figlio di Costantino fino al 325. La sua vicenda personale rappresenta il momento storico culturale, con le incertezze che hanno caratterizzato il IV secolo. Egli subisce da intellettuale la grande persecuzione di Diocleziano.
Negli anni della clandestinità, compone il De opificio Dei, a metà tra apologia e protrettico. Si rivolge al proprio allievo Demetriano per esortarlo a cercare nel mondo i segni della provvidenza divina nell’uomo, macchina perfetta che deve rinviare ad un artefice perfetto. Egli vuole ricollegarsi a Cicerone per integrare la trattazione antropologica e cita il De re publica, il De legibus e il De natura deorum. L’opera presuppone un ambito culturale filosofico. Lattanzio, a differenza di Cicerone che dà importanza ad una tradizione di pensiero di ascendenza platonica, vuole recepire i dati ed integrarli tramite l’impostazione di tipo aristotelico e dossografico- cioè quei concetti filosofici che si elaborano senza precisi connotati di scuola e legati a dottrine diverse. Il cristianesimo esercita una profonda influenza ed interviene nel dibattito ideologico del periodo, originando delle interpretazioni non propriamente ortodosse, ma neanche pagane. Dobbiamo presupporre una cospicua influenza degli scritti cristiani sull’uomo. Anche il titolo dell’opera è a metà tra paganesimo e cristianesimo, perché l’immagine di un dio creator è affiancata all’immagine di un dio opidex, vicina alla matrice platonica. Gli spunti profani restano confinati a livello di suggestione letteraria e filosofica. L’intento principale dell’opera è quello di descrivere l’azione della provvidenza nell’esame della fisiologia e anatomia umana, allo scopo di convertire. Lo slancio protrettico è favorito dal momento critico in cui il trattato viene composto: quando le condizioni esterne sono avverse, il cristiano ha bisogno di sentire che il Dio in cui crede è capace di un’azione provvidenziale favorevole all’uomo.
Nel 304-311 scrive un’opera importante che si richiama alla pratica di confezionare manuali dal titolo generico di Institutiones, alle quali egli aggiunge l’aggettivo divinae e in questo consiste l’importanza storica e teologica dell’opera. Il trattato si rivolge a due interlocutori fittizi, un filosofo pagano e un giudice che perseguita i cristiani. Ognuno dei sette libri è dedicato ad un tema che viene esposto, approfondito attraverso gli exempla. Il genere apologetico fa sentire la propria influenza nella divisione tra pars destruens e costruens (prima abbiamo l’inconsistenza delle teorie pagane e poi la vera esposizione dei libri). Lattanzio parte dalle accuse mosse al paganesimo e termina con la trattazione del premio della vita eterna. Lattanzio, secondo Gerolamo, riesce a mettere in evidenza i limiti del paganesimo, ma come Arnobio sembra vivere le contraddizioni di un’epoca di passaggio e ne mostra le incertezze nelle oscillazioni delle opere. Sottolinea, anche, nel proemio del V libro, la semplicità dello stile delle Sacre Scritture che hanno causato l’allontanamento dei colti dagli argomenti trattati. Gli auctores di riferimento per Lattanzio sono tutti pagani e costituiscono l’intermediario tra il pubblico degli intellettuali e le verità di fede e non esita a rinunciare all’autorità della Bibbia: primo tra tutti è Cicerone filosofo.
Lattanzio compone, a richiesta di Pentadio- frater- una sintesi della sua opera principale, l’Epitome divinarum institutionum, in cui l’autore abbrevia anche drasticamente numerose argomentazioni, con l’intento di chiarire meglio il proprio pensiero.
Scrive anche due trattati sulle proprie riflessioni sull’intervento di Dio nella storia dell’uomo. Si tratta di opere che potrebbero essere definite storiche, tuttavia la riflessione sui dati storici e cronachistici è sostenuta dall’intento apologetico e dalla volontà di chiarire i concetti dal punto di vista teologico. Il De ira Dei sostiene che Dio è capace di ira e si può essere puniti da Dio in caso di peccato. L’argomentazione è condotta in polemica con lo stoicismo che vuole la divinità buona e non irosa, e con l’epicureismo, per cui la divinità non è né buona né irosa. La fonte principale è ancora Cicerone. Il De mortibus persecutorum risale agli anni successivi alla fine della persecuzione di Diocleziano ed è dedicato a Donato. Lo scopo è quello di dimostrare la miserevole sorte dei sovrani persecutori dei cristiani e di sensibilizzare l’imperatore Licinio: è la prima opera nell’ambito della letteratura cristiana nell’alveo della storiografia. Lo stile è inedito, è una scrittura espressiva e frammentata. Le frasi nominali sono frequenti.
Lattanzio scrive anche un componimento elegiaco sulla fenice, mitico uccello che rinasce una volta morto. La storia dell’uccello nasce in ambito profano e viene adottata dalle posizioni religiose che intendono usare come edificante il concetto della persecuzione della vita dopo la morte. La fenice simboleggia per i pagani la sopravvivenza dell’anima e per i cristiani la risurrezione. Il testo è sprovvisto di segnali riconducibili a precise teorie filosofiche o all’ideologia cristiana: per il lettore pagano l’opera è una ripresa poetica di temi tradizionali e, per il cristiano, si ha il riuso di temi profani a finalità cristiane. L’attribuzione del poemetto a Lattanzio è stata fortemente messa in dubbio e risale a Gregorio di Tours. Nell’opera mancano riferimenti specifici ed espliciti alla dottrina cristiana, ma il simbolismo cristiano costituisce una possibile chiave di lettura.
Gerolamo riconosce a Lattanzio un magistero stilistico fino ad allora mai riscontrato tra gli autori cristiani e riconducibile a Cicerone. Lattanzio critica la lingua dei predecessori nel quinto libro delle Divinae Institutiones e questo costituisce un progetto letterario e pedagogico: bisogna dotare il cristianesimo di una lingua colta. Il referente è costituito dalle orazioni ciceroniane. Gli umanisti del XV secolo parlano di Cicerone Cristiano: il ciceronianismo dell’autore non è chiuso a influssi letterari contemporanei, ma diventa poi consueto nel medioevo. Egli rappresenta il culmine di una tendenza all’imitatio di Cicerone che si era già manifestata in Minucio Felice e che costituisce uno dei legami più profondi con una tradizione classica.
Decimo Magno Ausonio nacque a Burdigala – Bordeaux - nel 310 e viene istruito nella scuola da grammaticus a Tolosa, presso lo zio Arborio. Intraprende lui stesso la professione di grammatica e retorica. Nel 365 diventa precettore di Graziano, figlio dell’imperatore Valentiniano I. Le inclinazioni di Graziano a favore del Cristianesimo allentano tutti i rapporti di Ausonio con la corte, anche se il retore fa pubblica dichiarazione di fede. Dopo l’uccisione di Graziano, Ausonio si ritira nella sua città natale. È con Ausonio che possiamo considerare perfezionata la concezione della poesia come ars e lusus.
Compone innanzitutto i Parentalia, un’interessante collezione di trenta ritratti poetici di parenti scomparsi. Il poeta eredita la tradizione degli antichi elogia, coniugandola a motivi tipici dell’elegia e dell’epigramma funerario. Celebra la virtus degli affetti privati.
Anche l’Epicedion in patrem, compianto in distici elegiaci scritto dopo la morte del padre, appartiene al genere d’ambito funebre. Scrive il De herediolo, in cui descrive una vita serena che porta il suo stesso nome. Al nipote indirizza il Genethliacus, carme per il suo compleanno e gli dedica il Protrepticus, un’esortazione allo studio. Uno dei suoi componenti più significativi è costituito dall’Ephemeris, raccolta poetica in metro vario ben illustrata, in cui Ausonio dedica componimenti a ripercorrere la propria giornata dal risveglio fino al momento di coricarsi, illustrando le occupazioni più pratiche. La tiepidezza della fede cristiana si avverte anche nei Versus Paschales, che espongono il dogma della fede in occasione della Pasqua. Scrive anche il Gratiarum actio, cioè l’orazione di ringraziamento a Graziano per la carica rivestita, attento ai moduli del genere del panegirico. Scrive un ciclo di componimenti in metro vario dedicati a Bissula, la giovane schiava donata al poeta da Valentiniano. Compone diverse lettere ed è interessante il suo carteggio con il suo allievo Paolino- vescovo di Nola. Da maestro scrive anche diverse opere di carattere scolastico. Tra le opere personali e quelle scolastico-erudite, si situa la Commemoratio professorum Burdigalensium, 26 componimenti poetici in cui applica la formula dei medaglioni sperimentata nei Parentalia. La parola commemoratio rappresenta un termine speciale perché indica la commemorazione funebre e potrebbe indicare la volontà di rinnovare il genere della laudatio con toni tipici della poesia funeraria epigrafica. Gli insegnanti vengono valutati in secondo piano, non come dispensatori di letteratura, ma come conoscitori. Alcune opere di Ausonio risentono di una innegabile impostazione scolastica in diversi aspetti strutturali e compositivi. Ricordiamo l’Ordo urbium nobilium, una raccolta di componimenti esametrici dedicati ad illustrare le venti città più famose dell’impero. Riserva alcuni interessi anche per gli storici e gli economisti. Nei Caesares tratta una materia largamente condivisa dalla contemporanea produzione in prosa e ripercorre la successione degli imperatori da Cesare a Elagabalo. Ricordiamo anche gli Epitaphia, brevi commemorazioni funebri degli eroi della guerra di Troia.
L’opera che meglio corrisponde al gusto erudito del tempo sono le Eclogae, non in riferimento alla poesia bucolica, ma al significato del termine greco, allusivo alla varietà dei contenuti. Teodosio, in una lettera al poeta, si dichiara ammirato per il suo ingenium e la sua eruditio. L’ingenium deriva, infatti, dalla conoscenza professionale delle forme della letteratura precedente. Finalizzare la produzione artistica all’arte stessa è un carattere tipico della letteratura del periodo e ai nostri occhi Ausonio interpreta il gusto del suo tempo. L’autore prova un sotitle piacere nel lusus poetico che quasi tutti i versificatori del III e IV secolo perseguono. L’aderente imitazione virgiliana è una realtà del Cento Nuptialis, una raccolta centonatoria di componimenti che seguono le regole del genere e descrivono i vari momenti di un matrimonio. L’autore presenta il testo stesso come una risposta da letterato a un’operetta scritta da Valentiniano. Sicuramente il dato più interessante è il compiacimento mostrato dal poeta a indugiare sugli aspetti lascivi dell’unione matrimoniale. Il fatto che usi le parole di Virgilio rivela un altro aspetto di lusus. Scrive anche un poemetto esametrico, Griphus ternarii numeri, che gioca sul numero tre con erudita ricerca di variazioni nei campi più diversi: il titolo deriva dal sostantivo greco che significa rete di giunchi e anche enigma. Risente anche del trattamento del mito di tradizione virgiliana e ovidiana anche il Cupido Cruciatus, ispirato a un dipinto raffigurante il dio dell’amore, torturato dalle eroine del mito che sono state le sue vittime. Scrive il Ludus septem sapientum, dove ludus significa spettacolo. Ausonio è anche autore di più di cento epigrammi in metro diverso e trattante tematiche disparate. L’abilità del poeta è quella di coniugare l’invenzione formale all’osservanza dei modelli e gli autori latini di riferimento vengono superati in direzione degli antecedenti greci. L’ars ausoniana si manifesta nella traduzione ma anche nella composizione generale in greco. Ricordiamo l’Oratio consulis Ausonii versibus rhopalicis, che tratta i temi centrali del cristianesimo e dimostra attenzione sulla squisitezza medica. Importante è ance il Technopaegnion- raccolta esametrica in cui i carmi si compongono di versi che terminano con un monosillabo o con le lettere dell’alfabeto.
La Mosella è stata composta intorno al 370, è stata riconosciuta sin da subito il capolavoro del poeta. Simmaco ne giudica divina l’arte. Il titolo riproduce il fiume sul quale Ausonio ha viaggiato con Valentiniano e Graziano si ritorno a Treviri, dopo la campagna contro gli Alamanni del 368. L’opera si situa all’interno del filone della poesia odeporica, che troviamo nel genere dell satira di Lucilio e Orazio e testimoniata anche da Lattanzio. Al viaggio sono riferiti solo i primi 23 versi e l’autore si dedica subito alle lodi del fiume, offrendo un’ampia descrizione di quadri dell’ambiente. Le lodi del fiume, condotte secondo la retorica del locus amoenus possono rivelare anche la suggestione per la forma solenne delle laudes e dell’encomio. Tutto rivela una grande sensibilità al mondo naturale. Il poemetto è diviso in tre parti. Nella prima abbiamo la descrizione vera e propria del viaggio, l’apostrofe alla Mosella e il catalogo dei pesci che guizzano nelle acque del fiume; nella seconda la descrizione del fiume corredata da divagazioni e nella terza il paesaggio naturale e umano delle rive. L’opera dà un’ulteriore prova di erudizione: il catalogo dei pesci viene citato come una piece di bravura artistica e documentazione storico naturalistica, che obbedisce al gusto del tempo per stilare compendi. La tecnica artistica dell’autore mostra grandi prove nella tendenza all’amplificazione retorica di un dato oggettivo, come la pesca nelle acque della Mosella. Usa, nella descrizione degli animali, un particolare color poetico che ne ingigantisce i tratti. L’autore ricava dal suo testo una sottile vena malinconica. Ausonio fa poesia da retore, è interessato al fatto letterario in quanto canale privilegiato di rapporto con gli auctores, con i quali stabilire un dialogo sullo stesso piano e cioè un modo comune di parlare e di poetare. Ausonio realizza il sentimento neoclassico che caratterizza i secoli III e IV, attualizzando la lezione nel proseguire e sviluppare gli spunti di carattere formale degli auctores nelle opere. Il sentimento della sua poesia a ricercato nella volontà di riferirsi continuamente al mondo della grande letteratura romana: un sentimento di pietas che riguarda la letteratura al pari della vita.
Su Claudio Claudiano possediamo le notizie che l’autore stesso ci fornisce. Nasce ad Alessandria intorno al 370, in un ambiente di grande tradizione letteraria greca e di significativa tradizione grammaticale. La sua formazione è specificamente rivolta all’attività di poeta. Nel 395 a Roma si distingue per aver composto un panegirico in onore dei consoli Olibrio e Probino, membri della gens Anicia. Si assicura l’ingaggio da parte di personaggi ragguardevoli del senato e si mostra sensibile ai contenuti della tradizione, capace di trattarli poeticamente trasformandoli da topos letterario ad elemento celebrativo della personalità. Arriva alla corte di Milano, dove viene apprezzato da Onorio e da Stilicone e ottiene titoli di prestigio. Non si hanno notizie certe sulla morte. È fuor di dubbio uno dei letterati più prolifici della latinità e scrisse almeno diecimila versi. È anche autore di opere in greco, sua lingua originaria, di cui abbiamo solo qualche frammento. La sua opera poetica, alla sua morte, viene suddivisa in due sillogi, a seconda della presunta portata dei componimenti e nasce la distinzione tra carmina maiora e minora. Le divinità pagane costituiscono un elemento portante della poesia claudianea, come di tutta la grande tradizione latina. perché rappresentano una comune topica letteraria espressiva e immaginifica. Claudiano, come Ausonio, fa professione di cristianesimo. Il genere del panegirico, nella letteratura latina, si presenta in prosa e sporadicamente offre esempi in versi. Claudiano lo tratta in poesia, applicando gli insegnamenti strutturali perfezionati nelle scuole di retorica, che prevedono una successione delle varie parti e in questo genere dà prova di versatilità.
Per il consolato di Stilicone scrive il De consulatu Stilichonis, in tre libri, i primi due recitati a Milano e il terzo a Roma. Sono ripresi i temi cari alla poesia tradizionale, l’encomio di Roma, ecc. Abbiamo la personificazione di Roma con l’aiuto di Minerva e il procedimento usato è quello della ekphrasis, risalente già ad Omero, ma attualizzato dalla colta poesia alessandrina. Un panegirico particolare è rappresentato dall’incompiuto elogio di Serena, nipote e figlia adottiva di Teodosio e moglie di Stilicone: la lode ha un risvolto politico non secondario. L’epitalamio è un’altra forma poetica praticata in latino per imitazione della letteratura greca. Scrive un epitalamio per le nozze di Onorio e Maria, figlia di Stilicone, accompagnato da quattro fescennini in metro vario che partecipano del diffuso gusto per la sperimentazione stilistica e metrica e per la pratica di generi letterari arcaici e poco usati. Di tradizione greca è il genere dell’invettiva, che va considerato un genere epidittico. Scrive due invettive che colpiscono ministri dell’Impero d’Oriente. nella prima, in due libri, denigra il consigliere di Arcadio e rovescia gli espedienti della retorica. L’invettiva contro l’eunuco Eutropio rappresenta al meglio l’antitesi dell’encomio. Il punto di partenza è la descrizione fisica del personaggio, improntata al ridicolo e al disgusto. Il trattamento personale del patrimonio tradizionale si rivela quando il poeta non si limita a recuperare il repertorio poetico consigliato dalla scuola e richiesto dal pubblico, ma lo arricchisce di schemi e di stilemi propri. I personaggi celebrati agiscono nello stesso mondo dei protagonisti della grande epica latina. il risultato è aumentare sensibilmente la portata encomiastica del panegirico. Tra le sue prime prove poetiche abbiamo una Gigantomachia in lingua greca, della quale abbiamo una settantina di versi e viene ripreso nella maturità in un poemetto in latino che riconduce alle esercitazioni nelle scuole. Il momento storico in cui l’impero viene minacciato dagli usurpatori, fa crescere l’ammirazione per la virtus eroica e i valori tradizionali di Roma e Virgilio e la tradizione epica imperiale rappresentano un’autorità di indubbio rilievo. La vocazione all’epica di Claudiano diventa un ottimo campo di prova.
Importante è il De raptu Proserpinae, in tre libri, di cui l’ultimo interrotto. Il poema tratta del rapimento della figlia di Cerere da parte di Plutone. Claudiano impreziosisce il tema con varianti del mito presenti nella tradizione greca. Il poeta mostra di obbedire alla retorica del genere, ma non si astiene dal mostrare la propria personalità esagerando tali situazioni topiche, come la costruzione di lunghi discorsi dall’impostazione retorica che eliminano il dialogo. La sua sensibilità epica si rivolge anche all’attualità politica e alla propaganda. Il genere epico diventa uno strumento in tale direzione, prestandosi a trattare argomenti in grado di mettere in buona luce i personaggi cari all’autore e orientare l’opinione pubblica. I critici hanno osservato che l’epica storica claudianea contiene aspetti indubbiamente encomiastici. Nel III libro del De consulatu Stilichonis raffigura il suo protettore nelle vesti di Scipione in costante compagnia del poeta Ennio, definito doctus. Il rapporto tra l’uomo politico e il padre dell’epica latina finisce per adombrare quello fra Stilicone e il campione dell’epica contemporanea.
Claudiano compone due poemi storici, entrambi relativi a fatti bellici in cui Stilicone viene presentato come l’eroe dell’impero che difende Roma dalle insidie esterne. Nel Bellum Geticum, il poeta tratta della campagna condotta contro i Goti di Alarico e culminante nella battaglia di Pollenzo del 402. Claudiano connota la celebrazione costante di Stilicone assimilandolo via via agli eroi della grande storia repubblicana di Roma. Il Bellum Gildonicum, incompiuto, si riferisce, invece, all’insidia ordita da Eutropio ai danni di Stilicone nel 398, quando il potente ministro dell’impero d’Oriente convince Gildone a interrompere i rifornimenti di cereali a Roma dall’Africa. Claudiano considera il proprio ruolo di poeta coerentemente con la tradizione letteraria e chiede all’interprete delle Muse una parola lontana dalla quotidianità. Scrive un breve carme dedicato a Eternale, costruito sul topos del poeta invasato da Apollo. L’affermazione di poetica è evidente: egli non deve usare verba communia, ma una lingua legata alla tradizione letteraria e troviamo una affermazione in cui è presente il classicismo di tutti i tempi e la convinzione che esista uno statuto privilegiato del carmen che accomuna i poeti di tutti i tempi. Claudiano è molto sensibile alla lezione formale degli auctores, forse perché era egiziano e guarda alla tradizione con sguardo particolare. Nelle sue opere, mostra di assumere come modelli tutti i poeti della tradizione, da quelli arcaici ai repubblicani a quelli di età imperiale. La sua lingua costituisce un elemento fondante del classicismo dello scrittore perché sembra tenere conto di elementi emersi in tutta la tradizione poetica latina. la sua poesia si configura come poema epico e utilizza le situazioni letterarie del passato per occuparsi del presente: la tradizione non è il rifugio del letterato ma è una risorsa per parlare ai contemporanei. Calato nel centro del potere e della politica, il nostro autore parla al pubblico attraverso parole non comuni. In Claudiano, i contemporanei potevano vedere un poeta diverso da quelli che avevano cercato la protezione di qualche famiglia, un artista che procedeva sulla stessa linea degli auctores.
I grandi poeti della letteratura di IV secolo sono Ausonio e Claudiano, per la parte cristiana abbiamo Prudenzio e Paolino di Nola.
Aurelio Prudenzio Clemente è uno dei più grandi poeti cristiani latini, retore convertito ci ha informati riguardo i suoi fatti biografici all’interno di una Praefatio in versi che apre la sua raccolta poetica. Nasce in Spagna nel 348 e frequenta la scuola da grammatico per intraprendere la carriera di retore. Si reca a Roma per una questione personale e ricopre prima il ruolo di funzionario alla corte imperiale di Milano. L’esperienza della conversione è molto importante. Prudenzio parla di nequitia, termine che indica l’alienazione e la tendenza a vivere in un modo inautentico. Si tratta di un modello di conversione più vicino al concetto di cambiamento di vita e modo di pensare- come il termine greco metanoia. La sua è una produzione poetica vasta, sperimenta la lirica, l’epica e si presenta come un’opportunità per ottenere la salvezza dell’anima. Prudenzio diventa editore dei propri componimenti e cura anche una raccolta dei suoi scritti, disponendoli nell’ordine poi seguito dai manoscritti: apre la raccolta la Praefatio e la conclude un Epilogus. In ambito cristiano la lirica si manifesta come poesia innodica. Prudenzio compone testi letterari di alto livello per destinatari colti, educati alla lettura degli auctores pagani, in grado di apprezzare anche la letterarietà formale dei componimenti. Sono, infatti, molto estesi e la sintassi rappresenta un elemento di significativa distanza dagli inni ambrosiani molto semplici. L’apparato mitologico è sostituito dal soprannaturale cristiano e dagli exempla biblici.
Il titolo della sua raccolta è Cathemerinon, si tratta della trascrizione latina di un aggettivo che sottintende il sostantivo biblion- libro quotidiano. Gli inni sono 12 e sono divisi in due serie, la prima è una serie di coppie di inni per i tre momenti del giorno previsti dalla liturgia, la seconda è relativa a particolari momenti o feste della vita cristiana. L’inno prevede una precisa scansione e troviamo anche la funzione di preghiera e di edificazione morale e teologica. Troviamo una parte descrittiva che cede il passo ad una di tipo dottrinale. Le scelte metriche riportano ad Orazio, nonostante riproduca la struttura cantabile degli inni ambrosiani (quattro dimetri giambici). Questa è osservata nei primi due e negli ultimi due inni della raccolta, secondo un disegno compositivo inteso a racchiudere gli altri.
Prudenzio scrive una seconda raccolta di inni, in metro vario, dedicati ai martiri. Il titolo, Peristèphanon, è la trascrizione di un’espressione greca corrispondente al latino De coronis: l’immagine della corona rimanda infatti alla tradizione pagana, secondo la quale ai soldati valorosi, veniva concessa una corona come massimo riconoscimento, lo stesso che i cristiani attribuiscono ai martiri. Comprende 4 inni di varia estensione e diversa impostazione. Compone i suoi inni ai martiri non solo in metro diverso, ma secondo un’ottica di genere diversa l’uno dall’altro. Troviamo un componimento in distici elegiaci che è un’iscrizione di modello damasiano destinata al battistero di Calagurris. La raccolta è importante anche dal punto di vista dell’agiografia: Prudenzio attinge anche a notizie possedute in ambito cristiano, anche se in molte occasioni la versione presente non ha altri corrispettivi e rappresenta un documento di grande interesse. Importante è anche la tendenza al colorismo delle immagini che abbiamo notato in Claudiano, obbedisce qui al gusto delle tinte forti nelle efficaci scene drammatiche del martirio dei santi: il compiacimento anche eccessivo ha uno scopo ideologico.
Il gusto pittorico di Prudenzio nel racconto viene perseguito nel Dittochàeon, 49 componimenti esametrici di quattro versi ciascuno, dedicati a illustrare un episodio dell’Antico o del Nuovo Testamento. Si ispira alle raffigurazioni presenti nei vari luoghi di culto visitati a Roma o scriverebbe un commento poetico continuo a un unico ciclo figurativo. Secondo alcuni sarebbero destinati a fungere da didascalia alle raffigurazioni stesse. Il titolo greco si riconduce ai termini dittòs e ochè (doppio e nutrimento) e l’opera alluderebbe al doppio nutrimento che viene all’anima dalla meditazione sugli episodi dei due Testamenti della Bibbia.
Si confronta anche con il genere epico: le opere rimanenti nel suo corpus sono scritte in esametri e il metro narrativo è quello della tradizione poetica. Prudenzio guarda agli auctores della scuola e della letteratura e si misura con il genere epico. Questo si presenta nella forma comprensiva che accoglie in sé elementi di generi diversi- come il panegirico, la storia o l’invettiva. La rilevanza della tradizione cristiana è evidente anche all’interno delle opere di Prudenzio, in cui è implicito il richiamo alla tradizione. Nei poemi dottrinali è evidente che Prudenzio si richiama a Tertulliano e alle sue opere in materia di ortodossia contro le eresie. Si tratta di questioni già affrontate dai cristiani tra il II e il III secolo. Importante è la figura di Priscilliano che costituisce una vera e propria auctoritas per Prudenzio, tanto da trattare l’eresia di Priscilliano e l’arianesimo.
Importante è l’Apotheosis, un poema dipendente dall’Adversus Praxean tertullianeo: il titolo consiste in una parola greca che significa trasformazione in dio e allude alla santificazione a cui può arrivare chi tende a contemplare la vera essenza del Dio uno e trino. Il trattato polemizza contro chi sostiene che il Padre ha sofferto sulla croce insieme al Figlio e accusa anche gli ebrei di aver chiuso per timore gli occhi non comprendendo la divinità di Cristo al punto da metterlo a morte. La trattazione degli argomenti è varia e Prudenzio si avvicina particolarmente allo stile di Lucrezio quando istituisce un paragone tra il soffio divino e la respirazione dell’uomo. Troviamo un breve carme in esametri sul dogma trinitario, che però alcuni hanno ritenuto essere un’opera a sé. Si potrebbe trattare anche di un contributo da parte del poeta alla moda di usare le praefationes poetiche a trattati o a scritti in prosa.
Prudenzio scrive anche l’Hamartingenia, cioè l’origine dell’errore- cioè del peccato. L’argomento è anticipato dalla prefazione in senari giambici, che paragona Marcione a Caino. L’argomentazione principale riguarda la concessione all’uomo del libero arbitrio da parte di Dio.
Nel corpus prudenziano troviamo anche due opere in esametri con finalità dottrinale, comune a tutta la sua produzione. La prima si riallaccia alla tradizione apologetica cristiana dei secoli precedenti; la seconda prende come modello Virgilio e gli altri epici classici nelle sezioni dei loro poemi in cui si narano e interpretano i sogni. In entrambi il poeta persegue la confutazione dell’errore e l’edificazione della vera sapienza accompagnata dalla virtù. Il Contra Symmachum è suddiviso in due libri in cui Prudenzio decide di dimostrare l’inconsistenza del paganesimo e sostiene le ragioni cristiane. Il libro I è dedicato alla confutazione generale della religione dell’antica Roma e alla dimostrazione che p grazie al Dio cristiano che l’impero fa fronte alle minacce. La trattazione è prolissa. L’apologia di Prudenzio riprende dei topoi consolidati nella tradizione cristiana. Il momento storico deve far riflettere sulla verosimiglianza di una finalità meno generica, cioè la polemica simmachiana. L’autore sembra voler rovesciare le accuse provenienti dall’aristocrazia di tradizione pagana. La Psicomachia si mantiene su un terreno di contrasto: è un poema allegorico che tratta la battaglia tra i vizi e le virtù dell’anima del cristiano e fornirà una specie di modello per la letteratura allegorica medievale e per l’arte figurativa. Troviamo la battaglia tra le personificazioni delle virtù e dei vizi. Prudenzio fa costante riferimento al modello virgiliano e dall’Eneide derivano sicuramente certe precise espressioni. Il suo intento è proprio quello di fondare la nuova Eneide cristiana, in aperto contrasto con quella di Virgilio: Prudenzio è consapevole di ereditare dal padre dell’epica augustea le strutture fondamentali che governano le situazioni e il linguaggio del genere.
La produzione poetica di Prudenzio è stata considerata da Von Albrecht enciclopedica. Se guardiamo all’edizione delle opere curata dallo stesso autore, la sequenza dei componimenti mostra un’architettura di studiata simmetria. Nella raccolta poetica sono rappresentati generi letterari diversi ereditati dalla tradizione classica: ha la tendenza a rimescolare i generi letterari. Sembra voler ripercorrere tutte le forme poetiche degli auctores e cristianizzarli. Troviamo compiuta l’espansione cristiana negli ambiti poetici tradizionali. Riprende addirittura interi versi dei poeti più presenti alla memoria letteraria dell’autore e li riadatta. Va sicuramente considerato un poeta doctus: la lettura continua dei classici gli ha trasmesso lo stesso gusto per le forme letterarie della tradizione pagana condivisa con altri letterati del suo tempo. il poeta usa anche termini di impronta oraziana o virgiliana e arcaizza le parole- ricordiamo olli per illi. È figlio del suo tempo e la sua tendenza all’espressionismo, patetico e truce è estremamente caratterizzante. Nel 1700 veniva definito il Virgilio e l’Orazio dei cristiani.
Marco Calzoli
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022. Ha dato alle stampe con varie Case Editrici 51 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web.
Libri pubblicati da Riflessioni.it
RIFLESSIONI SUL SENSO DELLA VITA 365 MOTIVI PER VIVERE |
|