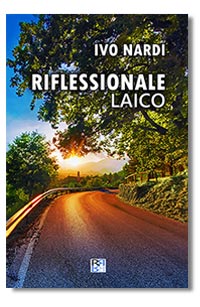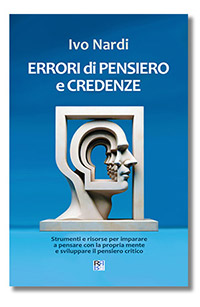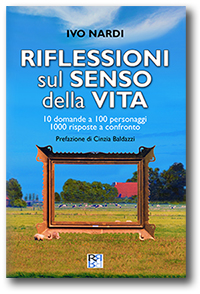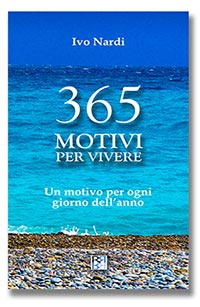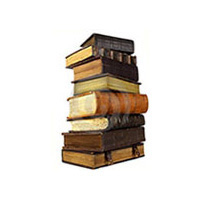
Riflessioni Filosofiche a cura di Carlo Vespa Indice
La poesia latina e l'amore
di Marco Calzoli - Aprile 2025
Publio Ovidio Nasone (43 a.C.-17 d.C.) è un autore romano immenso, si pone sia entro la tradizione greca e latina, è un eminente enciclopedista, ma è anche facitore di miti, non solo ma canta l’amore con una schiettezza e una profondità che sembra a volte essere un nostro contemporaneo. Il vero classico non smette mai di dire quello che ha da dire. Per di più, egli si pone anche in un atteggiamento di libertà: mentre il semplice poeta canta le storie e la politica le commissiona per scopi propagandistici, Ovidio ha anche ricercato il senso della parola e dell’arte poetica. Ovidio inoltre dà voce a ciò che non piace ai tradizionalisti, cioè va contro il costume sessuale tradizionale e lo fa con una genialità letteraria che incanta ancora oggi. Ovidio scriveva in poesia tutto ciò che voleva, egli cantava con finezza letteraria anche argomenti licenziosi senza che la cifra poetica ne venisse meno. Nell’Ars amatoria Ovidio scriveva cose che non sarebbero piaciute a chi promulgò la legge contro l’adulterio, e lo faceva con tale eleganza stilistica, ironia e delicatezza che non scatenò l’ira dei politici. Grande abilità retorica! Ovidio era retore ma anche giurista, quindi aveva un controllo sofisticato della parola e del concetto, inoltre era anche un grande poeta, che faceva zampillare poesia da argomenti persino scabrosi.
Le “Heròides” di Ovidio sono una raccolta intitolata alle autrici fittizie dei testi raccolti quindi delle eroine del mito, una raccolta di epistole metriche. Si tratta di una delle molte riscritture del mito che gli autori antichi facevano. Con questa raccolta Ovidio attua, all’interno della propria produzione, il passaggio dalla elegia autobiografica alla elegia mitologica.
Quando parliamo di elegia autobiografica pensiamo ai suoi Amores, concepiti inizialmente in 5 libri e poi pubblicati in 3 libri nei quali raccoglie tutte le elegie relative alla propria vicenda amorosa, nello stesso modo di Tibullo e Properzio.
Nella sua elegia autobiografica che parla del suo amore per Corinna, secondo la topica del codice elegiaco, c’è la donna amata che domina, appellata con uno pseudonimo, c’è la tematica dell’abbandono e c’è anche il mito, soffocato dall’io del poeta che narra e che ha la funzione di exemplum. Vale a dire che il mito è usato come breve esempio, ha cioè una funzione detta paradigmatica paradigmatico, il mito è volto a correlare l’esperienza biografica vissuta dal poeta a una vicenda famosa che conferisce a quell’esperienza personale un tenore universale.
Il mito nell’elegia autobiografica non va oltre questo. Invece nelle Heroides assistiamo a una ipertrofia del mito: tutto è mito, tutto si fa mito. La vicenda mitica copre l’intera epistola elegiaca.
Il mittente dell’epistola è una eroina del mito, e la vicenda che narra come se fosse autobiografica è la vicenda mitica che la riguarda, il destinatario è un personaggio del mito, non c’è più posto per la realtà e tutto si fa mito.
In questa ipertrofia risiede la novità della versificazione nelle Heroides, ma risiede anche nella forma epistolare che l’elegia viene ad assumere.
Un primo tentativo in questo senso era già stato fatto da Properzio: cercare di conferire forma epistolare a una elegia. Properzio però l’aveva fatto esclusivamente in relazione ad una elegia soltanto, la numero 3 del IV libro:
Haec Arethusa suo mittit mandata Lycotae
Aresia invia al suo Dicota queste raccomandazioni
La raccomandazione è simile all’incipit delle Heroides. Prima di Ovidio però nessuno aveva tentato una raccolta composta esclusivamente di elegie in forma epistolare. Ovidio prende tale iniziativa nel momento stesso in cui scrive gli Amores e ne abbiamo testimonianza nel verso 345 ss:
vèl tibi còmposità cantètur Epìstula voce;
ìgnotum hòc aliìs ille novàvit opùs
Oppure sia cantata da te l’Epistola con voce impostata;
egli rinnovò quest’opera ignota agli altri
In questo distico elegiaco è importante il nesso composita voce perché l’epistola che poi sarà quella in versi delle Heroides, se è cantata con “composita voce” non ha nulla a che vedere con l’epistolografia in versi di Orazio (anche lui scrive epistole metriche, tuttavia con un tono e un’affabilità che le fa rientrare all’interno di un genere dimesso, humilis, che rimane a terra; l’epistolografia oraziana fa il paio con la satira oraziana).
L’epistola elegiaca, invece, che Ovidio vuole tentare deve essere espressa con voce impostata: chi si esprime con voce impostata oggi sono I cantanti lirici, al tempo erano gli attori tragici. Quindi Ovidio si ispira ad un salto di genere, conducendo l’epistolografia in versi dal genere basso, limitrofo alla satira, al genere alto (soggetti mitologici e versificazione impostata, propria della tragedia limitrofa all’epica).
Ovidio vuole tentare un innalzamento e nel far questo ritiene di dover fare un’operazione nuova, di rinnovare dall’interno il genere elegiaco. Cerca di guardare ad altri generi che gli consentano di esprimere in modo nuovo la sua epistola in versi con soggetti mitologici, attinge a diversi generi facendo sì che si realizzi un genere che è mixto, una commistione di generi.
Adesso leggiamo brevemente Ovidio, Heroides, 16 vv. 53-88:
Est locus in mediis nemorosae(1) vallibus Idae
devius(2) et piceis ilicibusque frequens,(3)
55qui(4) nec ovis placidae nec amantis saxa(5) capellae,
Nec patulo tardae carpitur ore bovis.(6)
Hinc ego Dardaniae muros excelsaque tecta
et freta prospiciens arbore nixus eram.(7)
Ecce pedum pulsu visa est mihi terra moveri
60 -Vera loquar veri vix habitura fidem-(8);
Constitit ante oculos actus velocibus alis
Atlantis magni Pleionesque nepos(9)
-Fas vidisse(10) fuit, fas sit mih(11)i visa referre(12)-
Inque dei digitis aurea virga(13) fuit,
65tresque simul divae, Venus et cum Pallade Iuno,
graminibus teneros imposuere pedes.
Obstupui, gelidusque comas erexerat horror(14),
cum mihi: "Pone metum(15)”, nuntius ales ait(16);
arbiter es formae; certamina siste dearum,
70 vincere quae forma digna sit una duas;"
Neve recusarem(17), verbis Iovis imperat et se
protinus aetheria tollit in astra via.
Mens mea convaluit subitoque audacia venit
nec timui vultu(18) quamque(19) notare meo.
75Vincere erant omnes dignae iudexque(20) querebar
non omnes causam vincere posse suam;
sed tamen ex illis iam tunc magis una placebat,
hanc esse ut scires, unde movetur amor
tantaque vincendi cura est ingentibus ardent
80 iudicium donis sollicitare meum.(21)
Regna Iovis coniunx, virtutem(22) filia iactat(23):
Ipse(24) potens dubito fortis an esse velim.
Dulce Venus risit(25): "Ne te, Pari, munera tangant
utraque suspensi plena timoris, ait;
85 nos dabimus(26) quod ames et pulchrae filia Ledae(27)
ibit in amplexus pulchrior illa tuos."
Dixit et ex aequo(28) donis(29) formaque probata(30)
Victorem caelo(31) rettulit illa pedem.
Traduzione
“C’è un luogo in mezzo alle vallate dell’Ida boscoso solitario e fitto di abeti e di lecci che non è pascolo non è brucato dalla bocca/ non è pascolo né della pecora mansueta né di una capretta che preferisce I luoghi rocciosi né del lento bue (Letteralmente: che non è brucato dalla grande bocca di un bue né di una pecora né di una capra; luogo incontaminato= come lo specchio d’acqua dove non si abbevera nessun animale in Narciso). Da qui io appoggiato ad una pianta a guardare di fronte a me le mura della città di Dardano (Troia) e gli alti tetti e il mare. Ed ecco da un colpo di piedi mi parve che la terra si muovesse (sente dei passi, imponenti = epifania ). Dirò cose vere ma tali da avere a stento la credibilità del vero. Ristette davanti agli occhi sospinto dalle ali veloci il nipote del grande Atlante e di Pleìone. Fu lecito vederlo e mi sia lecito riferire ciò che fu visto da me.
E uno scettro d’oro era fra le dita del dio (e impugnava una verga dorata) Al contempo tre divinità, Venere e, insieme a Pallade (Atena), Giunone, posero I loro teneri piedi sull’erba .
Rimasi stupito e la paura che fa rabbrividire mi drizzò in testa I capelli al che il volatile messaggero mi disse “non avere timore tu sei arbitro di bellezza: poni fine ai conflitti delle dee,”à giudica su quale sia degna di vincere per bellezza sulle altre due”. Affinché io non rifiutassi comanda con le parole di Giove (Mercurio dice che il giudizio è voluto da Giove) e poi subito si leva per le vie aeree su verso le stelle. Il mio animo rinvigorì, e improvvisamente mi giunse l’audacia né ebbi timore di osservare/notare ciascuna (divinità) con il mio sguardo. Erano tutte degne di vincere e io da giudice (predicativo del soggetto) mi rammaricavo che non tutte potessero vincere la loro causa. Tuttavia, già allora, fra quelle ce n’era una che mi piaceva di più e perché tu sappia chi sia costei ebbene è quella dalla quale è mosso l’amore. Era tanto forte la preoccupazione di vincere che bramano di sollecitare il mio giudizio con grandi doni. La moglie di Giove e Minerva si vantano di poter offrire una il regno, l’altra il valore militare e io dubito se voler essere potente oppure forte e Venere sorrise dolcemente “o Paride non ti seducano I doni l’uno e l’altro pieni di timore che procura ansia” dice “ Noi ti daremo ciò che tu ami(cioè il dono dell’amore) e la figlia della bella Leda (Elena) Ella, persino più bella, verrà nei tuoi abbracci!(cadrà tra le tue braccia) Così disse, e prescelta sia per i doni sia per la bellezza ella riportò al cielo il piede vincitore”.
Si tratta di un mito assai antico, che Ovidio riscrive in maniera magistrale.
L’amore è una delle forze potenti che muovono il mondo. Platone definiva Eros mega daimōn, “dio potente”.
Freud vedeva nella libido la pulsione primaria della vita psichica, quella che muove ogni nostra emozione e ogni nostro pensiero, anche se non ne siamo consapevoli. Jung ruppe con Freud proprio a causa della libido, vista dal primo non in senso squisitamente sessuale ma molto più esteso, anche a livello simbolico e artistico.
L’amore è quanto di più spontaneo ci possa essere nella nostra vita. Lo psicoanalista Winnicott osservava come la ragione del vivere si trova nella nostra possibilità di esprimere noi stessi.
L’amore represso si trasforma in odio. Quindi nell’inconscio amore e odio sono le due facce della stessa medaglia. I criminologi sostengono, infatti, che le persone sono veramente loro stesse solo in due occasioni: nel sesso e nell’omicidio.
Marco Calzoli
NOTE
1) Nemorosae: nemorosus: boscoso: pieno di ricco di→ osus è il suffisso dell’abbondanza e va inteso come “pieno di, ricco di (luogo)”
21) Devius: lontano dalle vie comunemente battute, il luogo è solitario come già nel mito di Narciso devia rura
3) Rideterminazione di nemorosus: ricco di alberi tra i quali spiccano abeti e lecci; indica quali alberi ci sono in maggioranza
4) Qui: che, si riferisce a locus
5) Saxa: i luoghi rocciosi
6) Descrive un luogo incontaminato come lo specchio d’acqua di Narciso
7) Qui Paride è pastore. Sta fermo a guardare la città che ha abbandonato e ci dà un prospetto di quello che succederà alla città dopo l’evento che sta per avvenire
8) È un tipo di inciso messo per creare aspettativa
9) È il Messaggero degli dei, figlio di Atlante e di Maya, Mercurio
10)Vidisse: Infinito perfetto ma dal valore atemporale. Fu lecito vederlo a colpo d’occhio, valore puntuativo, dell’istante
11) Mihi: si trova all’interno di un costrutto che si chiama apo koinù,à in comune, dativo d’agente, costrutto che non si usa solo nella perifrastica passiva ma anche vicino a qualsiasi forma passiva del verbo. Fu lecito a me / ciò che fu visto da me
12) Referre: infinito di tempo presente, non più perfetto perché il racconto si dilunga nel tempo successivo a questo, ha bisogno di un tempo continuato
13) Aurea virga: tipica del dio Messaggero ma anche ma anche tipico del dio psicopompo, che accompagna le anime nell’aldilà = quanto si sta per verificare condurrà ad un esito dal finale funesto. È il dio psicopompo ad introdurre Paride al giudizio che porterà alla fine di Troia
14) Horror: non è la paura che paralizza ma quella che terrorizza e fa drizzare i capelli in testa
15) Metum: metus paura di un avvento esterno motivato dalla paura dell’arrivo di queste tre dee
16) Gioca tra sostantivo e aggettivo: alato messaggero
17) Non è facile il compito e c’è il timore che Paride possa rifiutare. La Recusatio è una figura ricorrente della poesia augustea, si tratta del rifiuto espresso dal poeta augusteo chiamato dal principe a scrivere qualcosa secondo i dettami della sua propaganda. L’uso del verbo non è quindi casuale e Paride si trova nella stessa posizione del poeta che deve rifiutare un ordine che arriva dall’altro e a volte questo rifiuto non è possibile. Es. Quando Porperzio è invitato a comporre epica, rifiuta (tramite la recusatio) e si dedica all’elegia.
18) Vultu: qui ha significato di “sguardo”, come fa Virgilio quando aumenta il pathos della narrazione
19) Quamque: ciascuna, sottointeso divinità
20) Iudex: e io da giudice, predicativo del soggetto
21) Esce l’ironia dell’autore. Ci fa capire che Paride ha già scelto e non avrebbe avuto bisogno dei doni per scegliere.
22) Virtutem: valore militare
23) Iactat: viene dal verbo iacio+ frequentativo to, che significa gettare, mettere sul piatto; è una sorta di metafora. La iactatio è però anche la figura retorica della vanteria, quindi lanciare e rilanciare verso l’alto
24) Ipse: opposizione, prende le distanze dai doni
25) Venere sorride dolcemente: ha un atteggiamento molto diverso da quello delle altre dee
26) Nos dabimus: noi ti daremo. Non dice Ego. Usa il plurale perché nos è un plurale sociativo. Venere quando usa questo plurale unisce a sé Paride, è un plurale che esprime una funzione fatica, di accesso all’interlocutore attraverso espressioni ammiccanti (già il sorriso e il chiamarlo per nome), come a dire “perché non ci scegliamo l’amore invece che il potere e la glori militare? Perché non facciamo questo tipo di scelta?”. L’interlocutore viene così fatto amico. Queste strategie (sorriso, chiamarlo per nome, nos sociativo) servono a far capire il carattere ammiccante di Venere seduttrice
27) Poteva chiamare Elena in molti modi e invece sceglie “figlia della bella Leda”. Infatti lì è presente Giunone, moglie del marito infedele Giove che aveva sedotto e amato Leda trasformandosi in cigno, e da quell’unione era nata Elena. Quindi Venere qui si prende gioco di Giunone, Elena è la figlia del tradimento, lo fa per farle rabbia
28) Ex aequo: allo stesso modo, è stata scelta per i doni e per la bellezza allo stesso modo
29) Donis: in realtà il dono è uno: l’amore di Elena. Ma questo plurale ha valore stilistico e intensivo: è un dono che vale per molti
30) Probata: prescelta
31) Caelo: cielo dovrebbe essere complemento di moto a luogo ma è reso con un dativo direzionale.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022. Ha dato alle stampe con varie Case Editrici 51 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web.
Libri pubblicati da Riflessioni.it
RIFLESSIONI SUL SENSO DELLA VITA 365 MOTIVI PER VIVERE |
|