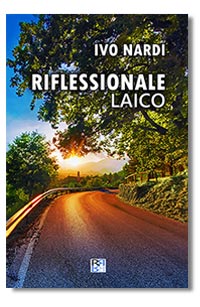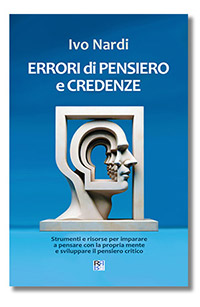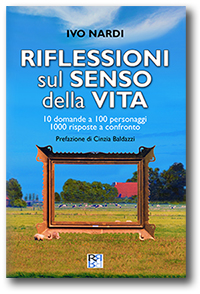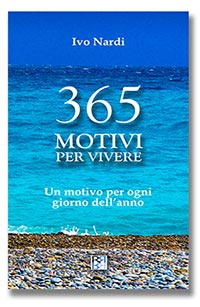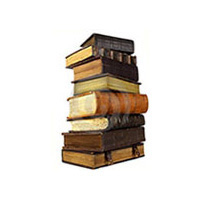
Riflessioni Filosofiche a cura di Carlo Vespa Indice
La lingua del Vangelo secondo Luca
di Marco Calzoli - Settembre 2025
Tutto il Nuovo Testamento ci è giunto redatto in greco, nella koiné ellenistica, l’ultima fase del greco antico.
Il Vangelo secondo Luca(1) è il più lungo dei vangeli, composto da 19.404 parole con 2.055 vocaboli diversi (gli Atti invece hanno 18.374 parole). Il Vangelo di Luca è senza dubbio il migliore. Scritto in un greco elegante e sofisticato, pienamente in regola con i canoni letterari della prosa ellenica più elevata. A ciò contribuì senza ombra di dubbio la estrazione sociale e la cultura personale: Luca, infatti, era un medico e non era di origine palestinese, essendo della Siria, un territorio profondamente ellenizzato(2). Non dimentichiamo, inoltre, che egli era stato collaboratore di Paolo, una persona, anch’essa, colta ed estremamente attenta al mondo greco.
Luca utilizza ancora l’ottativo(3) e presenta la colta costruzione del “periodo”. Elenchiamo una serie di altri tratti, grammaticali, sintattici e retorici, che ben inseriscono l’opera lucana nel contesto di una ricercatezza stilistica pienamente in regola con la letteratura greca più elevata:
- l’uso del participio futuro, presente soprattutto negli Atti (dove troviamo anche la sola presenza neotestamentaria dell’infinito futuro, se eccettuiamo Ebrei 3, 18), ma attestato anche in Lc 22, 49;
- participio predicativo del soggetto del tipo έλαχε εισελθών (1, 9), che ritroviamo in 5,4; 7,45; 9, 25; 10, 25; 18, 18.36;
- pronome indefinito τις in unione con un nome o un pronome (10, 25; 12, 16; 14, 2.16; 15, 4.11; 16, 1.19);
- aggettivo avverbiale (21, 34; 24, 22);
- indefinito τις al posto del numerale εις (per esempio in 18, 18; 21, 2; 22, 56), di contro alla tendenza tipica del greco ellenistico di sostituire il solito indefinito con il numerale;
- αρα invece del tipico ellenistico τί ότι (18, 8);
- la presenza della forma ω davanti al vocativo (24, 25);
- attrazione in frase relativa (per esempio 2, 20; 3, 19; 9, 36.43);
- la congiunzione δέ è usata molto spesso (si calcola addirittura che Luca, in loci simili con Marco, la preferisce al semplice καί ben ventisei volte);
- la congiunzione τε, pochissimo frequente negli altri evangelisti, è usata da Luca spesso e, secondo la forma classica, unita a καί fra parole affini logicamente (12, 45; 22, 66; 23, 12);
- aggettivo verbale, attestato nel Nuovo testamento solo in 5, 38;
- la espressione classica del tipo πολλα μεν ουν και έτερα (3, 18);
- la espressione classica ειπεν δέ invece di και ειπεν, di minor tenore stilistico (10, 28);
- un ellenismo come la relativa complessa (in Luca presente soprattutto negli Atti), ovverosia quell’idiomatismo greco che esprime un particolare rapporto fra un participio che precede e condiziona e un verbo principale che segue, secondo questa struttura principale (perché vi sono varie tipologie di relative complesse): verbo antecedente la relativa; verbo della relativa al participio; verbo principale che risulta essere determinato nella sua funzione logica dal participio (per esempio in 13, 19. 21; Atti 12, 4; 17, 23; 22, 5)(4);
- ipallage (2, 13);
- epanadiplosi (8, 24; 10, 41);
- litote (7, 6; 15, 13);
- endiadi (2, 47; 6, 48; 21, 15);
- ironia (22, 25; 23, 35);
- paronomasia (8, 5);
- chiasmo (15, 32).
Aggiungiamo la consistente presenza del genitivo assoluto, pur non essendo assente nel greco biblico (fra Vangelo e Atti si calcola una frequenza di 1 ogni 17 versetti), la presenza della correlazione con μέν .. δέ, molto spesso assente negli altri autori biblici. Dawsey ricorda anche l’infinito con articolo in genitivo per esprimere uno scopo (come in 2, 24), ως invece di πως nelle interrogative indirette (come in 8, 47), πρίν con il congiuntivo (come in 2, 26), l’articolo prima di una interrogativa indiretta (come in 1, 62)(5).
L’analisi comparativa del Vangelo secondo Luca con pagine di autori greci rivela molte linee in comune. Per fare un esempio, c’è una stretta relazione tra 15, 25-32 e l’Anabasi di Senofonte (1. 4. 12): fra le caratteristiche in comune ricordiamo solo l’uso dell’ottativo (Senofonte ha un ottativo obliquo del discorso indiretto, έσοιτο, mentre Luca presenta un ottativo potenziale, αν είη) e la congiunzione καί ad inizio di frase come nesso di coordinazione. Non solo ma Alfred Vogeli(6) compara lo stile del Vangelo secondo Luca e degli Atti con la letteratura greca artistica, riconoscendovi una distinzione all’interno di tutti gli scritti neotestamentari: “Betrachtet man die Schriften des NT unter literalischem Gesichtspuntkt, so muss man ja einraumen, dass Sprache, Stil und Art der Darstellung im lukanischen Doppelwerk eine gewisse schriftstellerische Kunst und damit einen gewissen Anspruch auf Bildung verraten”. Anche se l’autore riconosce che, soprattutto per la tematica della ripresa di elementi dionisiaci, “einer direkten Beziehung von ‘Lukas und Euripides’ “si risolva “im verneinenden Sinne”(7), tuttavia in appendice rimanda a tutta una serie di rapporti fra Luca e Omero (Vangelo secondo Luca 23, 53ss.; Iliade V, 302 ss. e XII, 445 ss.), e poi Filostrato (Atti 17), Luciano (Atti 27), Virgilio (Atti 9), Arato (Atti 17, 27) e così via.
Tuttavia occorre notare che Luca è uno scrittore greco della decadenza, quindi la sua lingua è fortemente influenzata dai fenomeni degenerativi tipici della koiné ellenistica. A ciò si aggiunga una buona messe di semitismi, inerenti sia il lessico sia la costruzione della frase. Per di più Antoniadis(8) intitola un capitolo del suo studio sulla lingua e lo stile del Vangelo secondo Luca così: “La langue de Luc considérée comme intermédiaire entre le grec classique et le grec moderne”. Nella sua analisi, infatti, l’autore francese tende a far notare sì le somiglianze con gli autori classici, ma anche le inevitabili divergenze, provenienti dall’influenza della lingua parlata(9). Solo per fare qualche esempio l’espressione presente in 1, 39 (dove ανίστημι è usato con il senso di “eseguire un proposito”) ricorda un modo di dire del greco moderno (σηκώθηκα και πηγα και του ταπα όλα ) che indica letteralmente l’azione dell’alzarsi, dell’andare e del dire per esprimere questo concetto: “j’ai pris cette ferme résolution: j’ai été le trouver et lui dire tout “. Oppure in 12, 49 abbiamo πυρ βαλειν, che potrebbe richiamare l’espressione del greco moderno βάζω φωτιά.
Nel dettato lucano si ritrovano quasi tutte le caratteristiche della koiné ellenistica in genere e del Nuovo Testamento in particolare. Pensiamo soltanto a forme tipiche della koiné sia della declinazione (συγγενίς invece dell’attico συγγενής in 1, 36; il dativo γέρει invece del regolare γηρα sempre in 1, 36; l’accusativo κλειδα invece di κλειν in 11, 52), della coniugazione (forme medie in forma attiva: γελάσω in 6, 21; ποιω in 5, 29; forme medie in forma passiva: απεκρίθη in 4, 4), dell’uso dell’aumento (omissioni: Atti 2, 25; μέλλω e δύναμαι hanno l’aumento ellenistico in ε come in 1, 22), dell’uso del raddoppiamento (in 6, 48 incontriamo la forma οικοδομησθαι invece di quella regolare in ωκ-), dei tempi (nuovi presenti: αφίομεν – che suppone il presente in αφίω, invece di αφίημι – in 11, 4; nuovi futuri derivanti dall’aoristo secondo: come φάγομαι invece di έδομαι in 14, 15; nuovi aoristi: come ηξα in 13, 34, invece di εισαγαγειν, pure usato in 2, 27), della sintassi (αυτός con il senso possessivo-riflessivo: 14, 17; από con genitivo d’agente e di causa: 9, 22 e 22, 45; του che accompagna il genitivo completivo senza la sua funzione genitivale: 4, 10).
Basta una semplice analisi di un brano per accorgersi quanto la lingua di Luca si allontani dalla lingua classica. Per esempio, consideriamo 18, 35-43, ove sono presenti sette particolarità ellenistiche e semitiche: εγένετο + verbo principale, che è una costruzione paratattica semitizzante tipica della Septuaginta; εν τω εγγίζειν, semitismo insieme a verbo postclassico; participio tautologico λέγων; επετίμων ίνα σιγήση, la congiunzione in luogo dell’infinito è costruzione tipica della koiné ellenistica; σταθείς, forma passiva tipica della koiné ellenistica; προς αυτόν, con uso riflessivo; al v. 40 c’è un genitivo assoluto improprio; al v. 41 un’altra volta ίνα usata in luogo dell’infinito.
Pertanto, in base a tutto quanto osservato, riguardo alla lingua di Luca, possiamo parlare di un greco elegante e che si rifà a molti moduli e forme classiche, tipici di una lingua alta e colta: cosa che lo innalza di molto dalla maggior parte degli altri scrittori neotestamentari. Il greco migliore del Nuovo Testamento è costituito da Luca e dalla Lettera agli Ebrei
Tuttavia osserviamo anche la presenza di spiccati tratti della koiné ellenistica e spiegabili anche per influsso semitico, cosa che fa senza ombra di dubbio inquadrare Luca nell’alveo degli scrittori ellenistici, naturalmente di livello.
Anzi, è veramente caratteristico lo strano impasto di forme ellenistiche e semitizzanti da una parte e di forme eleganti dall’altra. A testimonianza ricordiamo soltanto che nel brano testé preso in esame si scorgono ben tre tratti tipici della lingua classica alta ed elegante: al v. v. 36 ακούω + genitivo; al v. 36 subordinata in ottativo obliquo; al v. 37 la subordinata completiva ha il verbo al presente, come discorso diretto, anziché al passato come è il verbo della principale.
Approfondiamo brevemente la questione dei semitismi nel Vangelo secondo Luca(10).
Il Vangelo di Luca offre una enorme differenza linguistica fra il prologo (1, 1-4) e il resto del Vangelo: mentre i primi quattro versetti dell’opera sono scritti in un greco impeccabile, che sarebbe potuto essere stato composto con la penna di un qualsiasi scrittore ellenico, la restante parte letteraria è enormemente influenzata da semitismi (al dettato fa eco la parte tematica, percorsa da idee e allusioni tipicamente semitiche e veterotestamentarie), addirittura in maniera maggiore rispetto agli altri sinottici(11).
Sparks(12) scrive che, per spiegare questa grande messe di semitismi (si trovano addirittura “peculiarly Lukan Semitisms“), non si possono che adombrare tre ipotesi: 1. il Vangelo, a parte il prologo, è una traduzione greca di un originale semitico; 2. i semitismi provengono dall’uso di fonti semitiche; 3. Luca ha volontariamente semitizzato il dettato greco.
La prima ipotesi può essere scartata perché gli studi contemporanei hanno dimostrato che Luca si è servito per la composizione del Vangelo di due fonti principali, il Vangelo di Marco e la Q, scritte entrambe in greco.
Tuttavia, osserva lo stesso Sparks nella seconda parte dell’articolo, alcune fonti secondarie in aramaico (come la cosiddetta “fonte L” e una tradizione orale) hanno sicuramente influenzato Luca nell’adottare uno stile semitico in punti dove l’evangelista sembra assumere il materiale dalle suddette due fonti (per fare un esempio, in 4, 16 compare la costruzione perifrastica ην τεθραμμένος: è un costrutto, sì, anche del greco extrabiblico e di quello della Septuaginta, però è altresì un aramaismo, molto probabilmente dipendente dalla fonte perché la fraseologia è usata all’inizio della sezione editoriale). Quindi per Sparks la questione si spiega preferibilmente in base alla seconda ipotesi, ma non solo.
Anzitutto, si sa che, essendo di lingua madre aramaica sia Gesù sia i discepoli, le prime fonti erano in aramaico: quindi Marco e Q forse erano traduzioni in greco o, per lo meno, molto dipendenti dallo stile semitico di partenza. Pertanto molti semitismi penetrarono nel Vangelo in relazione a quelli presenti nelle due fonti di Luca: per esempio, la Q (vd. Matteo 10, 28) aveva la forma semitica φοβουμαι con από + genitivo, ripresa anche da Luca 12, 4.
In secondo luogo, bisogna anche osservare che in alcuni passi Luca semitizza deliberatamente (per esempio mentre Marco presenta una costruzione in linea con la lingua greca in 12, 4 –αποστέλλω + accusativo dell’oggetto diretto –, Luca in 20, 11 presenta una struttura che non si ritrova in greco in quanto semitica: προστίθημι con infinito). Sui motivi di questo atteggiamento si possono fare solo congetture: da una parte, se può dipendere dalla tipologia del greco parlato allora in Palestina (che doveva avere molti tratti provenienti dal sostrato semitico), allora Luca può aver semitizzato coscientemente sulla linea del particolare greco di quelle regioni di allora; dall’altra, Spark ritiene molto probabile che Luca abbia ripreso deliberatamente lo stile della Septuaginta (“St. Luke himself was not a ‘Semitizer’, but an habitual, conscious, and deliberate ‘Septuagintalizer’ “.).
In conclusione, quindi, possiamo dire: 1. gli aramaismi in Luca sono ben pochi(13): si possono rintracciare solo due tratti tipici dell’aramaico, cioè la costruzione perifrastica formata da verbo essere più participio(14) (come in 15, 1) e il tipo “iniziare a fare qualcosa”, soprattutto “iniziare a dire” (come in 4, 21); 2. gli ebraismi, invece, sono in gran numero e provengono prevalentemente dalla Septuaginta, per cui Luca semitizza deliberatamente nel senso che ebraizza, soprattutto, il suo dettato.
Per completezza, ricordiamo che, in numero estremamente minore, si collocano tracce sparute di influssi siriaci(15). Intendiamo qui per siriaco non quella lingua liturgica e letteraria che nacque nel II sec. d. C. come codificazione del dialetto aramaico di Edessa(16), espressa in un alfabeto di ascendenza aramaica, per mediazione del palmireno, in due forme (estranghela, più arcaico, e serti, dal ductus corsivo) e che fu usata, per esempio, per la Peshitta(giungendo, grazie ai missionari nestoriani, fino in Cina: come nell’iscrizione di Hsi-an-fu), bensì, sommariamente, come quel tipo di aramaico parlato in Siria (da cui proveniva Luca) e che si differenzia, per alcuni aspetti, dall’aramaico palestinese(17). Connolly nota principalmente quattro tratti di un siffatto idioma (più uno per gli Atti(18): a. 12, 49: ει ήδη ανήφθη, espressione dura in greco, si spiega convenientemente con la grammatica siriaca; b. 14, 18: απο μιας: sintagma considerato unico nella letteratura greca, che si spiega senza problemi con il siriaco “men hedha”, “from one” (fem.), con il senso di “immediatamente, subito”; c. 13, 7; 13, 16; 15, 29: l’uso di ιδού per introdurre espressioni di tempo nel discorso diretto è un tratto siriaco (uso di “ha”, nel senso di “ecco”; invece l’ebraico e l’aramaico hanno rispettivamente “zeh” e “denan”, che significano “questo”); d. 5, 12; 5, 17; 8, 22; 13, 10; 20, 1: l’uso di εν μια των per indicare un luogo non meglio precisato (città, sinagoga…).
Aggiungiamo che il Vangelo secondo Luca è quello più influenzato dalla Septuaginta. Hawkins scrive che “Luke shows most familiarity with the LXX”, presentando, tra l’altro, ben 261 “peculiar words, of which only 73 … are markated”(19), in numero maggiore rispetto agli altri sinottici (Marco è il meno influenzato).
È chiaro che un tale rapporto ha inevitabilmente influito con la presenza particolare di alcuni semitismi. Sparks(20) elenca a proposito cinque particolarità che corroborano l’ipotesi di una particolare ascendenza di Luca rispetto alla traduzione greca:
- Luca mostra di citare l’Antico Testamento in base alla Septuaginta. Significativo il fatto che Luca se ne allontani soprattutto quando dipende da Marco o da Q (per esempio, Mc 1, 3 è ripreso da Lc 3, 4), mentre è estremamente fedele quando non dipende dalle fonti greche (23, 30) oppure quando espande una citazione derivata però dalle fonti (ad es., 3, 5-6);
- i nomi propri veterotestamentari corrispondono a quelli della Septuaginta. Con la sola eccezione di Ελισσαιος che Luca adotta al posto di Ελεισαιε presente nella traduzione greca, il terzo vangelo ha Ιερουσαλήμ, invece della forma Ιεροσόλυμα di Marco; in 4, 26 Luca preferisce la forma Σιδωνία che non appare in nessun altro testo greco eccetto 1Re 17, 9 nella traduzione della Septuaginta;
- il vocabolario: citiamo soltanto ενώπιον (una preposizione utilizzata con frequenza sola da Luca e dalla traduzione greca) e κοιλία che è usato nel senso di “utero” sette volte collegandosi al senso più comunemente attestato del termine nella Septuaginta (come in Gn 30, 2);
- la fraseologia: citiamo soltanto πορεύεσθαι οπίσω (Lc 21, 8 e Dt 6, 14) e ποιειν έλεος μετά (Lc 1, 72 e Gn 24, 12);
- alcuni passi paralleli con Marco sono trattati mediante il linguaggio della Septuaginta. Per fare un solo esempio: mentre Marco presenta l’espressione βλέπετε από (Mc 8, 15), Luca la sostituisce con προσέχετε από (Lc 12, 1), derivante dalla traduzione greca.
Sono state fatte svariate ipotesi per spiegare questa particolare dipendenza dalla Septuaginta. Gli studiosi le dividono in tre categorie principali:
- Torrey(21) spiega la grande messe di semitismi in Luca ritenendo che il Vangelo sia una traduzione di una fonte semitica (per cui non si dovrebbe parlare di septuagintismi, ma di semplici semitismi);
- Kennedy(22) e Sparks(23) sostengono che Luca ha deliberatamente imitato la traduzione greca;
- Black(24) ritiene che i septuagintismi non siano altro che appartenenti al più ampio contesto di uno specializzato linguaggio cultico, utilizzato e per la Septuaginta e per il Nuovo Testamento.
Tralasciando gli influssi più minuti (come προστίθημι che indica ripetizione –come in 19, 11 – conformemente all’uso ebraico del verbo dell’aggiungere + infinito), esaminiamo brevemente i septuagintismi più frequenti e caratteristici in Luca:
- και εγένετο (per Blass e Debrunner è il più caratteristico, insieme al secondo che proporremo(25); del resto, sono usati spesso insieme): la matrice è la particolare fraseologia ebraica formata da “e” + “accadde questo” + “verbo principale. Nel Nuovo Testamento ci sono tre varianti principali: 1. con verbo principale in un tempo all’indicativo passato (Mc 1, 9); 2. con και e una principale (Lc 5, 17); 3. con accusativo e infinito (Mc 2, 23). Degno di nota che il greco extrabiblico conosce le forme di γίγνομαι con accusativo e infinito (per esempio in Teognide si trova “γίνεται ευ ρειν έργ ανδρων”) e con ώστε e infinito (Isocrate usa “γένομεν ώστε και τους μείζω δύναμιν έχοντας κρατηθηναι”). Delebecque(26) individua tre forme principali in Luca: 1. εγένετο δέ + εν temporale + infinito o aoristo(27) (“la formule … porte la segnature de Luc, helléniste” poiché “elle est inconnue des Septante” e anche rispondente al “bon grec”); 2. εγένετο preceduto da καί o seguito da δέ + espressione temporale (nominale o verbale) + proposizione principale giustapposta(28) (“elle est évidemment tirée … des Septante, qui offrent … des centaines d’exemples”); 3. Anche questa formula “est traduite de l’hébreu par les Septante, qui en usent couramment “e”son premier élement est toujours l’impersonnel εγένετο, le second toujours une expression temporelle, mais le troisième élément, qui contient encore un second verbe principal, au lieu d’etre justaposé au premier, lui est coordonné par καί” (29);
- εν τω + infinito sostantivato con valore temporale: la matrice ebraica è la preposizione “be” che precede l’infinito costrutto per esprimere un senso generalmente temporale. Questo uso si ritrova principalmente nel terzo vangelo (32 volte; mentre in Matteo 3, in Marco 2, negli Atti 7, in Paolo 3, nella Lettera agli Ebrei 4), soprattutto in unione con la prima formula (εγένετο εν τω: 23 volte in Luca, mentre altrove solo 1 volta in Mc 4, 4), fraseologia che la Septuaginta utilizza per rendere l’ebraico “wajhi be” (30);
- και ιδού (“ed ecco”): mentre senza la “e” corrisponde ad un aramaismo (“hinneh”), con la “e” è un ebraismo perché usato dalla Septuaginta per tradurre in greco l’ebraico “wehinneh”. Forse è un costrutto anche aramaico (Moulton – Howard - Tourner). Johannessohn, dopo aver fatto un’analisi dell’espressione ebraica nei libri veterotestamentari “mit hebraischem Original” e “in den nur griechisch vorliegenden Buchern”(31), propone un’ampia rassegna nel Nuovo Testamento: nel Vangelo secondo Luca rileva che compare 15 volte(34).
- και αυτός (“e questi”): conformemente alla tipica espressione ebraica. In questo modo almeno lo intende Schweiter, che lo inserisce tra i semitismi più schietti (εγένετο con “e”, εγένετο con verbo finito, εν μια των, εν τω con infinito, και ιδού), rilevando una frequenza pari a 17 attestazioni nel Vangelo, mentre non compare per niente negli Atti(33). Invece Michaelis, che cita proprio il presente articolo, si dichiara contrario osservando dall’analisi dei testi che “sie mussen vielmehr και αυτός fur ihre Zeit als normales Griechisch angesehen haben”(34).
Marco Calzoli
NOTE
1) Per un orientamento di massima fra i principali studi di carattere letterario: J. V. BARTLET, The Sources of St. Luke’s Gospel: Studies in the Synoptic Problem, Oxford 1911; O. DA SPINETOLI, Luca, Assisi 1984; J. ERNST, Il vangelo secondo Luca, Brescia 1985; C. GHIDELLI, Luca, Roma 1986; M. J. LAGRANGE, Les sources du troisième évangile in “Revue Biblique “4 (1895) pp. 5-22 e 5 (1896) pp. 5-38; A. Q. MORTON – G. H. C. McGREGOR, The Structure of Luke and Acts, New York 1964; F. REHKOPF, Die lukanische Sonderquelle. Ihr Umfang und Sprachgebrauch, Tubingen 1959; K. H. RENGSTORF, Il vangelo secondo Luca, Brescia 1980; J. ROHDE, Die redaktionsgeschichtliche Methode (Theologische Arbeiten XXII) Berlin 1965; A. M. SALAZAR, Questions About St. Luke’s Sources in “Novum Testamentum” 2 (1958) pp. 316-317; J. STAUDINGER, Textus “primarius” Evangelii sec. Lucam in “Verbum Domini” 33 (1955) pp. 65-74.
2) Nel prologo apocrifo posto nel II secolo all’inizio di un testo del Vangelo troviamo una specie di carta d’identità: “Luca, siro-antiocheno, di arte medico, divenuto discepolo degli apostoli, che seguì Paolo sino al suo martirio e il Signore senza distrazione, non sposato, senza figli, morì in Beozia all’età di 84 anni, pieno di Spirito Santo”.
3) Non lo usa soltanto lui, però solo in Luca troviamo l’ottativo obliquo, una forma tipicamente letteraria e colta.
4) E. DELEBECQUE, L’hellénisme de la “relative complexe” dans le Nouveau Testament et principalement chez saint Luc, in “Biblica “ 62 (1981) pp. 229-238.
5) J. M. DAWSEY, The Lukan Voice. Confusion and Irony in the Gospel of Luke, Macon 1986, pp. 167-168.
6) A. VOGELI, Lukas und Euripides, in “Theologische Zeitschrift” 9 (1953) pp. 415-438.
7) Osserviamo che il Vangelo secondo Luca, molto attento al tema della misericordia e dell’amore, può, almeno idealmente, rapportarsi alla Medea di Euripide, nella quale, nonostante il tema tragico che è sviluppato, compaiono di volta in volta quasi tutte e quattro le principali radici greche dell’amore (forse per contrasto con l’argomento): εράω (come in 8 o 330), φιλέω (sia in senso proprio, che in collegamento con il valore etimologico “appartenente a”, come in 31 o 138), αγαπάω, στέργω (come in 88 o 635). Nel mondo classico i termini principali sono i primi due. Ερως è inteso sia individualmente (come una forza che porta verso una persona o cosa di cui si sente la mancanza e quindi si avverte il desiderio, non solo eroticamente –ad es., l’espressione έρως έχει με + infinito significa semplicemente “ho desiderio di” –, ma anche in questo senso – “innamorarsi” si può dire εις ερωτα αφικέσθαι di qualcuno) che cosmologicamente (per Empedocle è la forza che decreta l’essere). Interessante la sintesi che ne fa Platone: l’amore parte dal bello sensibile (inteso anche sensualmente) per portare alle Idee, che stanno alla base della realtà tutta. Φιλία indica l’affetto, l’amore della famiglia e dell’amicizia: la radice si ritrova in φιλαδελφία (la humanitas) e in φιλοξενία (l’amore dello straniero, quindi l’ospitalità). Invece gli ultimi due termini hanno il senso più sbiadito, indicando trattare con affetto, aver caro, preferire, accontentarsi (αγάπη) e apprezzare, gradire, amare (figli e genitori), accontentarsi, sopportare (στέργηθρον). Tuttavia nel Nuovo Testamento, mentre gli altri tre termini vengono a perdere d’importanza, la radice di αγαπάω viene assunta in un senso altissimo: come mostra il Vangelo secondo Giovanni 13, 34-35, indica il tratto distintivo del cristiano, sul modello di ciò che ha fatto Cristo con il sacrificio della croce (nella chiesa primitiva la celebrazione eucaristica era chiamata per l’appunto anche αγάπη). Uno studio fondamentale sulla semantica dei verbi dell’amare nel Nuovo testamento e sulle loro divergenze con la classicità è costituito da A. NYGREN, Eros e agape. La nozione cristiana dell’amore e le sue trasformazioni, Bologna 1971. Cfr. anche, fra i numerosissimi studi, C. SPICQ, Agapè dans le NT. Analyse des textes, 3 voll., Paris 1958-1959 e A. PENNA, Amore nella Bibbia, Brescia 1972.
8) S. ANTONIADIS, L’Evangile de Luc. Esquisse de grammaire et de style, Paris 1930, p. 333.
9) In S. ANTONIADIS, op. cit., pp. 381-390 si propone un confronto fra la lingua di Luca e il greco moderno.
(10) Invece per una visione generale dei semitismi degli Atti: H. F. D. SPARKS, The Semitisms of Acts, in “Journal of Theological Studies” nova series I (1950) pp. 16-28; M. WILCOX, The Semitisms of Acts, Oxford 1965. Per la bibliografia inerente il terzo vangelo vedi di seguito.
(11) Già il grande Lagrange osservava che “Luc est incontestablement celui des trios synoptiques qui contient le plus de tournures hébraisantes”, in Les Èvangile selon Saint Luc, Paris 1921, p. XCVII.
12) H. F. S. SPARKS, The semitisms of St. Luke Gospel, in “Journal of Theological Studies” 44 (1943) pp. 129-138.
13) Se si eccettuano ipotesi recenti che vedono il Benedictus, pronunciato da Zaccaria (che con molta probabilità parlava aramaico), come una composizione della quale “Lc presenta el texto griego como una interpretacion del pensamiento arameo”, quindi diffusamente percorso da tratti aramaici. Cfr. J. LUZARRAGA, El Benedictus (1, 68-79) a través del arameo, in “Biblica” 80 (1999) pp. 305-358. Non solo, ma altri studiosi pensano anche che i primi due capitoli dipendano strettamente da un originale semitico, la fonte della infanzia.
14) Come rileva lo stesso Sparks, era una costruzione non assente nel greco anteriore e presente anche nella Septuaginta. Tuttavia egli la include fra gli aramaismi per via della sua notevole presenza nel greco biblico a causa del calco di una espressione aramaica. Invece in A. VERBOOMEN, L’imparfait périphrastique dans l’Evangile de Luc et dans le Septante, Leuven 1992, soprattutto le pp. 73-86, si rileva che “d’aucuns pour qui l’influence stylistique de la Septante sur le grec de Luc s’est pourtant imposée comme une évidence, n’es continuent pas mois à qualifier la construction périphrastique d’aramaisme” (p. 73). Anzi, appare chiaro per Verboomen, che la costruzione perifrastica con l’imperfetto del verbo essere è un septuagintismo, poiché ricorre o con tutti o con alcuni dei quattro tipici septuagintismi (και εγένετο, εν τω + infinito, και ιδού, και αυτός non enfatico: ad es., con tutti e quattro ricorre in 14, 1-6).
15) R. H. CONNOLLY, Syriacisms in St. Luke, in “Journal of Theological Studies “37 (1936) pp. 374-385.
16) Ovvero il siriaco classico. Cfr. T. MURAOKA, Classical Syriac, Wiesbaden 1997.
17) Per una visione globale della realtà linguistica aramaica vd. F. ROSENTHAL, An Aramaic Handbook, 2 voll., Wiesbaden 1967; S. SEGERT, Altaramaische Grammatik, Leipzig 1975; M. SOKOLOFF (a cura di), Aramaeans, Aramaic and the Aramaic Literary Tradition, Ramat Gan 1983. Per l’aramaico biblico vd. L. PALACIOS, Grammatica aramaico-biblica, Montserrat 1980; I. JERUSALMI, The Aramaic Sections of Ezra and Daniel, Cincinnati 1978. Per l’aramaico palestinese vd. J. A. FITZMYER-D. J. HARRINGTON, A Manual of Palestinian Aramaic Texts, Roma 1978.
18) Atti 22, 25, dove ricorre προτείνω secondo un uso tipico del siriaco.
19) J. C. HAWKINS, Horae Synopticae, Oxford 1909, p. 198.
20) H. F. S. SPARKS, op. cit., pp. 132-134.
21) C. C. TORREY, Our Translated Gospels, New York 1936.
22) G. KENNEDY, Classical and Christian Source Criticism, in W. O. WALKER (a cura di), The Relationships Among the Gospels, San Antonio 1978.
23) H. F. D. SPARKS, op.cit.
24) M. BLACK, Second Thoughts IX: The Semitic Element in the New Testament, in “The Expository Times” 77 (1965) pp. 20-30.
25) F. BLASS – A. DEBRUNNER, Grammatica del Greco del Nuovo Testamento, Brescia 1997, p. 57.
26) E. DELEBECQUE, Ètudes grecques sur l’Èvangile de Luc, Paris 1976, pp. 123-165.
27) Per esemplificare vd. 3, 21.
28) Vd. 2, 1.
29) Vd. 19, 15.
30) F. BLASS – A. DEBRUNNER, op. cit., p. 490.
31) M. JOHANNESSOHN, Das biblische και ιδού in der Erzahlung samt seiner hebraischen Vorlage. A. wehinne “und siehe” bzw. και ιδού usw. im Alten Testament, in “Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung “66 (1939) pp. 145-195.
32) M. JOHANNESSOHN, Das biblische… B. και ιδού im Neuen Testament, in “Zeitschrift fur vergleichende Sprachforschung” 67 (1940) pp. 30-84.
33) E. SCHWEIZER, Eine hebraisierende Sonderquelle des Lukas?, in “Theologische Zeitschrift” 6 (1950) pp. 161-169.
34) W. MICHAELIS, Das unbetonte και αυτός bei Lukas, in “Studia Theologica” 4 (1950) pp. 86-93.
Marco Calzoli è nato a Todi (Pg) il 26.06.1983. Ha conseguito la laurea in Lettere, indirizzo classico, all’Università degli Studi di Perugia nel 2006. Conosce molte lingue antiche e moderne, tra le quali lingue classiche, sanscrito, ittita, lingue semitiche, egiziano antico, cinese. Cultore della psicologia e delle neuroscienze, è esperto in criminologia con formazione accreditata. Ideatore di un interessante approccio psicologico denominato Dimensione Depressiva (sperimentato per opera di un Istituto di psicologia applicata dell’Umbria nel 2011). Ha conseguito il Master in Scienze Integrative Applicate (Edizione 2020) presso Real Way of Life – Association for Integrative Sciences. Ha conseguito il Diploma Superiore biennale di Filosofia Orientale e Interculturale presso la Scuola Superiore di Filosofia Orientale e Comparativa – Istituto di Scienze dell’Uomo nel 2022. Ha dato alle stampe con varie Case Editrici 51 libri di poesie, di filosofia, di psicologia, di scienze umane, di antropologia. Ha pubblicato anche molti articoli. Da anni è collaboratore culturale di riviste cartacee, riviste digitali, importanti siti web.
Libri pubblicati da Riflessioni.it
RIFLESSIONI SUL SENSO DELLA VITA 365 MOTIVI PER VIVERE |
|